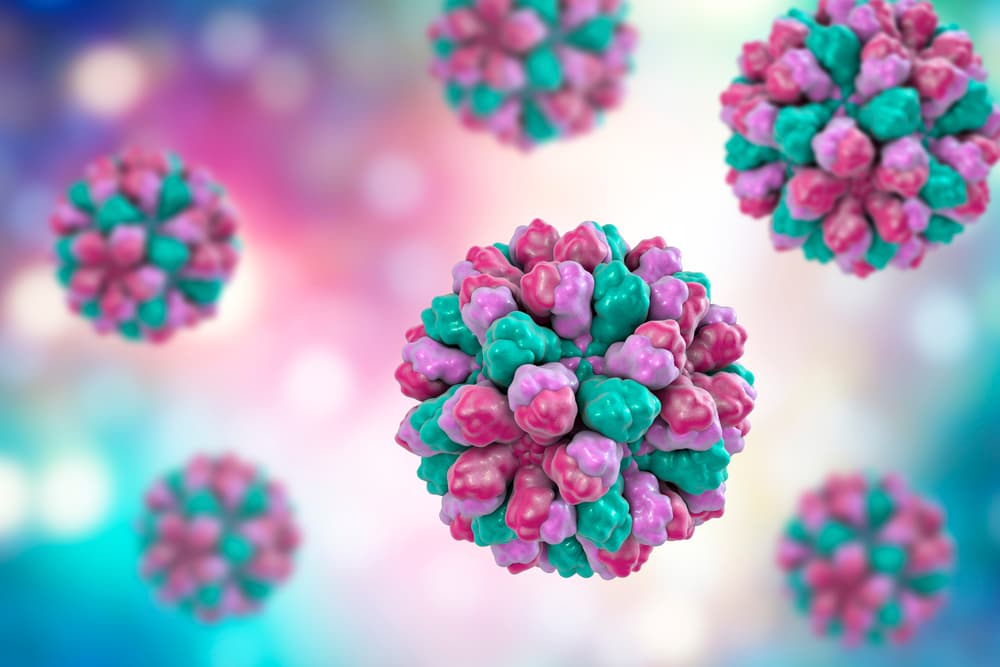Il bushmeat o commercio illegale di carne di animali selvatici oltre a consentire la diffusione di patogeni, favorendo un possibile salto di specie, contribuisce al rischio di estinzione di decine di specie animali. Qual è la situazione attuale e quali sono i rischi per l’uomo?
Bushmeat: una situazione nota da tempo
Già nel 2001 numerose associazioni ambientaliste internazionali, come il WWF, giornalisti come Piero Angela e David Quammen (l’autore di “Spillover” nel 2020), sul National Geographic1, denunciavano che il bushmeat, ovvero il commercio illegale di carne di animali selvatici stava dilagando perfino nei parchi nazionali africani ed era aumentato negli ultimi anni in maniera esponenziale; Quammen ipotizzava che le tre epidemie di Ebola che avevano imperversato a metà degli anni ’90 in alcuni villaggi africani fossero legate alla macellazione e consumo di carne di scimmia.
Il 13 gennaio 2004 al Parlamento Europeo l’ordine del giorno riguardava il commercio illegale di carne di animali selvatici (bushmeat); i deputati erano concordi sul fatto che ci si trovasse di fronte a una catastrofe che riguardava la sopravvivenza sia delle specie animali che delle popolazioni che dipendono dalle foreste per la propria sussistenza e che la carne di animali selvatici contrabbandata avrebbe potuto non solo causare nuove epidemie in Europa, ma anche esporre il bestiame a malattie ed epidemie del continente africano.
Sebbene sia noto da tempo che carne e pesce vengono importati illegalmente dall’Africa all’Europa, la portata del fenomeno del bushmeat è rimasta finora non quantificata; quindi, diversi studi sono stati condotti in questo senso.
In Europa un mercato emergente di traffico illegale di carni
Tra il 2017 e il 2018, un team di ricercatori ha fatto la spesa in cinque diversi mercati di Bruxelles, nei quali hanno comprato svariati pezzi di carne venduti come bushmeat2; i tagli sono stati acquistati e portati in laboratorio per analizzarne il DNA e ne sono emerse almeno tre diverse specie protette dal CITES: il cercopiteco nasobianco del Congo, il cercopiteco di Brazzà e una specie di piccola antilope chiamata cefalofo azzurro.

© Vladislav T. Jirousek – shutterstock.com.
Indagini sono state svolte sui bagagli dei passeggeri di alcuni aeroporti: Zavantem di Bruxelles, Roissy-Charles de Gaulle di Parigi, a Zurigo e Ginevra in Svizzera3,4,5, mediante esame del DNA ed esami radiografici.
La carne selvatica sequestrata (di non facile identificazione, dato che solitamente viene essiccata e affumicata) apparteneva prevalentemente a roditori, antilopi, maiali, pangolini e coccodrilli; tre specie rappresentavano quasi la metà dei sequestri campionati: l’istrice africano, il ratto delle canne e il pangolino dal ventre bianco; diverse specie rientrano nelle Appendici I (commercio vietato) e II (commercio limitato) del CITES. La Repubblica Democratica del Congo (RDC) sembra essere la principale fonte di bushmeat in base alla percentuale di passeggeri che trasportano carne selvatica; seguono Camerun, Togo, Repubblica Centrafricana, Costa d’Avorio, Nigeria.

© maxrlx-shutterstock.com.
Indagini condotte presso due aeroporti tedeschi negli anni 2010/20146 hanno dimostrato che l’introduzione di bushmeat, oltre che dall’Africa, avviene anche da Russia e Caucaso, Turchia e Medio Oriente. Dagli studi si evidenzia che le importazioni non avvengono esclusivamente per il consumo personale, ma alimentano un sistema organizzato di commercio e ciò è indicato dalle grandi dimensioni di molte singole spedizioni di carne selvatica e dalla presenza di commercianti a Parigi che sono in grado di fornire carne selvatica su ordinazione.
Nel 2021, per la prima volta, uno studio7 pubblicato su Nature Ecology & Evolution da un team di scienziati delle università di Sheffield, Gainesville (Florida) e della Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (Università norvegese di scienze della vita), ha tentato di sintetizzare le informazioni esistenti sino a quel momento (331 studi) su ciò che il bushmeat stava facendo alle popolazioni selvatiche: è emerso che il commercio internazionale di specie selvatiche sta causando un calo di circa il 62% nell’abbondanza di specie, con le specie in via di estinzione che subiscono un calo di oltre l’80%.
Bushmeat e zoonosi
Secondo l’OMS, il 75% delle malattie emergenti ha a che vedere con le specie selvatiche e la maggior parte dei circa 200 episodi di zoonosi conosciuti sono stati causati dal fenomeno del bushmeat.
Ad esempio, in America si registrano ogni anno più di 70.000 casi di salmonellosi da rettili, e più di 6.000 in Gran Bretagna; almeno 19 sono le pandemie riconducibili al commercio di fauna selvatica: si stima che abbiano infettato 1,4 miliardi di persone negli ultimi 100 anni causando circa 87 milioni di morti.
Virus
Numerose ricerche hanno documentato questo legame8,9,10; la carne selvatica è un’importante fonte di proteine e di reddito per molte popolazioni africane, ma le attività legate ad essa sono state ricondotte a numerose epidemie di EID (malattie infettive emergenti), come Ebola, HIV e SARS: di tutti gli EID, gli spillover zoonotici derivanti dalla fauna selvatica sono stati identificati come la minaccia più significativa e crescente per la salute globale.
Le attività di caccia e macellazione di animali selvatici sono un meccanismo chiave, anche se non l’unico, attraverso cui le popolazioni umane entrano in contatto con serbatoi di malattie che circolano allo stato selvatico, compreso il virus Ebola; tre epidemie iniziali del virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dal 1976 al 1979, hanno coinvolto vittime che, secondo quanto riferito, avevano maneggiato carcasse di gorilla occidentale o di scimpanzé comune o avevano avuto contatti fisici con persone che avevano toccato gli animali; il virus Ebola può rimanere vitale nelle carcasse non trattate fino a 3-4 giorni, quindi, esiste il rischio di trasportarlo nei mercati di carne selvatica.
Allo stesso modo, il virus Marburg è stato identificato per la prima volta nel 1967 e nel 1968 in operatori di laboratorio che avevano sezionato cercopitechi importati, prima a Belgrado e poi in Germania ed è riapparso nel 2022 in Ghana, probabilmente trasmesso da pipistrelli.11,12,13

© Sony Herdiana – shutterstock.com
Sebbene l’origine dell’HIV sia stata a lungo poco chiara, si ritiene che l’HIV-1 e l’HIV-2 umani si siano evoluti da ceppi del virus dell’immunodeficienza delle scimmie (SIV) e prove suggeriscono che il SIV sia stato trasmesso agli esseri umani attraverso il contatto con il sangue, quando i cacciatori avevano una ferita aperta o si ferivano durante la macellazione di primati non umani.14
Altri esempi di legame bushmeat-zoonosi sono la correlazione tra i virus della leucemia a cellule T umane (HTLV) e i virus T-linfotropici delle scimmie (STLV) 1 e 2, che contribuiscono all’emergenza degli HTLV umani,15,16 e i retrovirus Simian Foamy Virus (SFV), noti per trasmettersi agli esseri umani, che sono endemici nella maggior parte dei primati africani.17,18
Non va dimenticata l’emergenza o la ricomparsa di molte malattie zoonotiche, tra cui il vaiolo delle scimmie, la febbre gialla e la malattia di Lyme, la sindrome polmonare da hantavirus, l’influenza aviare (HPAI H5N1), la malaria e la tripanosomiasi africana umana. Vanno, poi, considerati gli henipavirus e altri paramyxovirus, come il virus Hendra, il virus Nipah (HNV), e il virus della rabbia e gli altri Lyssaviruses: si stima che circa 25.000 persone muoiano ogni anno in Africa a causa della rabbia19, parte delle quali potrebbe essere dovuta all’esposizione avvenuta in attività legate al bushmeat.
Batteri
Non bisogna dimenticare, poi, che il 54,3% degli eventi EID sarebbe di origine batterica20 e ci sono elementi che suggeriscono che i batteri patogeni siano altrettanto importanti dei virus, riguardo alla diffusione attraverso attività legate al bushmeat; in una rara indagine21, svolta sulle carni selvatiche vendute in Gabon è stata evidenziata la presenza di Salmonella.
Leptospira, che è endemica nell’Africa sub-sahariana e diffusa nei mammiferi selvatici, negli uccelli e nei rettili, presenta un alto rischio di diffusione mediante le attività legate bushmeat, dato che viene eliminata nell’ambiente con le urine.
Un ruolo può essere svolto anche da Bacillis anthracis, che è in gran parte una malattia dei mammiferi erbivori, ma alla quale sono sensibili anche gli scimpanzé comuni, e poi i batteri trasmessi da vettori, come Yersinia pestis, Rickettsiae, elminti, protozoi (es. Entamoeba histolytica e Balantidium coli negli scimpanzé comuni).

© Ari Wid – shutterstock.com
Sebbene quasi tutto il commercio di fauna selvatica presenti un certo livello di rischio zoonotico, alcuni gruppi tassonomici sono serbatoi ad alto rischio di agenti patogeni più virulenti: più alto per i pipistrelli, seguiti da vicino dai primati, quindi da ungulati e roditori. L’aumento dell’invasione umana negli ultimi decenni ha portato alcune specie di pipistrelli a diventare addirittura peridomestici, il che li rende facili bersagli per la caccia.
Le ricerche sulle carni di specie selvatiche importate illegalmente22 hanno evidenziato la presenza di batteri aerobi a livelli superiori a quelli considerati sicuri per il consumo umano, oltre all’identificazione di agenti patogeni zoonotici e livelli pericolosi di agenti cancerogeni nelle carni di pesci affumicati.
Fattori di rischio
La trasmissione delle malattie zoonotiche legate al commercio di carne selvatica può essere direttamente collegata a tre situazioni: la caccia (rischio medio), la macellazione (rischio elevato) e il consumo (basso rischio); in base al maggior o minor contatto con il sangue di animali infetti, la trasmissione microbica può verificarsi in più punti del processo di caccia e macellazione.
Durante la caccia gli individui sono più suscettibili a morsi e graffi da parte soggetti infetti, primati e roditori, soprattutto se presentano ferite aperte; inoltre, è più facile vengano cacciati o catturati animali malati, aumentando così la probabilità di trasmissione all’uomo.
L’esposizione attraverso tali comportamenti a rischio varia in base a diversi fattori: il sesso (le donne sono maggiormente coinvolte nella macellazione e lavorazione delle carni) e il tipo di attività.
Riguardo al consumo, pur se l’importazione illegale di carne rappresenta un potenziale rischio di introduzione di agenti patogeni, il rischio è più basso anche perché spesso la carne importata viene affumicata (il processo di affumicatura è il mezzo di conservazione più comune).23
Nonostante interventi, come l’operazione Thunder24 che, lanciata nel 2017, ha coinvolto le autorità doganali e di polizia di 133 Paesi e che, nel 2023, ha portato a oltre 500 arresti e a più di duemila sequestri di piante o animali iscritti nelle liste CITES e il cui commercio è vietato (ad es. migliaia di uova di tartaruga, 300 kg di avorio, dozzine di parti di grandi felini, scimmie, uccelli e specie marine), le indagini evidenziano che il trend è in crescita sia nei Paesi d’origine che come richiesta di esportazione, e che il trasporto illegale attraverso gli aeroporti non risulta particolarmente difficoltoso.
- D. Quammen, National Geographic marzo 2001 Vol. 199 n.3 – Africa Estrema ↩︎
- Gombeer S, et al. Exploring the bushmeat market in Brussels, Belgium: a clandestine luxury business. Biodivers Conserv. 2021;30, 55–66 (2021). ↩︎
- Chaber AL, et al. Examining the international bushmeat traffic in Belgium: A threat to conservation and public health. One Health. 2023;17:100605. doi: 10.1016/j.onehlt.2023.100605. ↩︎
- Chaber AL, et al. The scale of illegal meat importation from Africa to Europe via Paris. Conservation Letters, 2010;3(5) 317-321. doi/full/10.1111/j.1755-263X.2010.00121.x ↩︎
- Wood KL, et al. CITES-Listed Species at Risk from Illegal Trafficking in Bushmeat; Results of a 2012 Study in Switzerland’s International Airports. Tengwood Organization, 2014. ↩︎
- Jansen W, et al. The Quantity and quality of illegally imported products of animal origin in personal consignments into the European union seized at two german airports between 2010
and 2014. PLoS One. 2016;11(2):e0150023. doi: 10.1371/journal.pone.0150023. ↩︎ - Morton O, et al. Impacts of wildlife trade on terrestrial biodiversity. Nat Ecol Evol. 2021;5(4):540-548. doi: 10.1038/s41559-021-01399-y. ↩︎
- Kurpiers LA, et al. Bushmeat and Emerging infectious diseases: lessons from Africa. Problematic Wildlife. 2015;507-doi:10.1007/978-3-319-22246-2_24 ↩︎
- Cleaveland S, et al. Overviews of pathogen emergence: which pathogens emerge, when and why? Curr Top Microbiol Immunol. 2007;315:85-111. doi: 10.1007/978-3-540-70962-6_5. ↩︎
- Kilonzo C, Stopka TJ, Chomel B. Illegal animal and (bush) meat trade associated risk of spread of viral infections. In: Singh SK, editor. Viral Infections and Global Change. Hoboken: Wiley; 2014. pp. 179–194. ↩︎
- LJ. Stojkovi et al., Two Cases of Cercopithecus-Monkeys- Associated Haemorrhagic Fever. In: Martini, G.A., Siegert, R. (eds) Marburg Virus Disease. Springer, Berlin, Heidelberg. ↩︎
- Martini et al. 1968 ↩︎
- Sah R, et al. Marburg virus re-emerged in 2022: recently detected in Ghana, another zoonotic pathogen coming up amid rising cases of Monkeypox and ongoing COVID-19 pandemicglobal health concerns and counteracting measures. Vet Q. 2022;42(1):167-171. doi: 10.1080/01652176.2022.2116501. ↩︎
- Hahn BH, et al. AIDS as a zoonosis: scientific and public health implications. Science. 2000;287(5453):607-14. doi:10.1126/science.287.5453.607. ↩︎
- Courgnaud V, et al. Simian T-cell leukemia virus (STLV) infection in wild primate populations in Cameroon: evidence for dual STLV type 1 and type 3 infection in agile mangabeys (Cercocebus agilis). J Virol. 2004;78(9):4700-4709. doi:10.1128/jvi.78.9.4700-4709.2004 ↩︎
- Sintasath DM, et al. Simian T-lymphotropic virus diversity among nonhuman primates, Cameroon. Emerg Infect Dis. 2009;15(2):175-184. doi:10.3201/eid1502.080584 ↩︎
- Boneva RS, et al. Simian foamy virus infection in a blood donor. Transfusion. 2002;42(7):886-91. doi: 10.1046/j.1537-2995.2002.00134.x. ↩︎
- Calattini S, et al. Simian foamy virus transmission from apes to humans, rural Cameroon. Emerg Infect Dis. 2007;13(9):1314-doi:10.3201/eid1309.061162 ↩︎
- Dodet B, et al. Human rabies deaths in Africa: breaking the cycle of indifference. Int Health. 2015;7(1):4-6. doi: 10.1093/inthealth/ihu071. ↩︎
- Jones KE, et al. Global trends in emerging infectious diseases. Nature, 2008;451: 990–993. doi.org/10.1038/nature06536 ↩︎
- Bachand N, et al. Public health significance of zoonotic bacterial pathogens from bushmeat sold in urban markets of Gabon, Central Africa. J Wildl Dis. 2012;48(3):785-9. doi:10.7589/0090-3558-48.3.785. ↩︎
- Chaber AL, Cunningham A. Public health risks from illegally imported African Bushmeat and smoked fish.EcoHealth. 2016;13:135–138. doi: 10.1007/s10393-015-1065-9. ↩︎
- Falk H, et al. llegal import of bushmeat and other meat products into Switzerland on commercial passenger flights. Rev Sci Tech. 2013;32(3):727-739. doi: 10.20506/rst.32.2.2221. ↩︎
- CITES: “Operation Thunder 2023: 2,114 seizures of endangered animals and timber in major international law enforcement operation” dicembre 2023. ↩︎