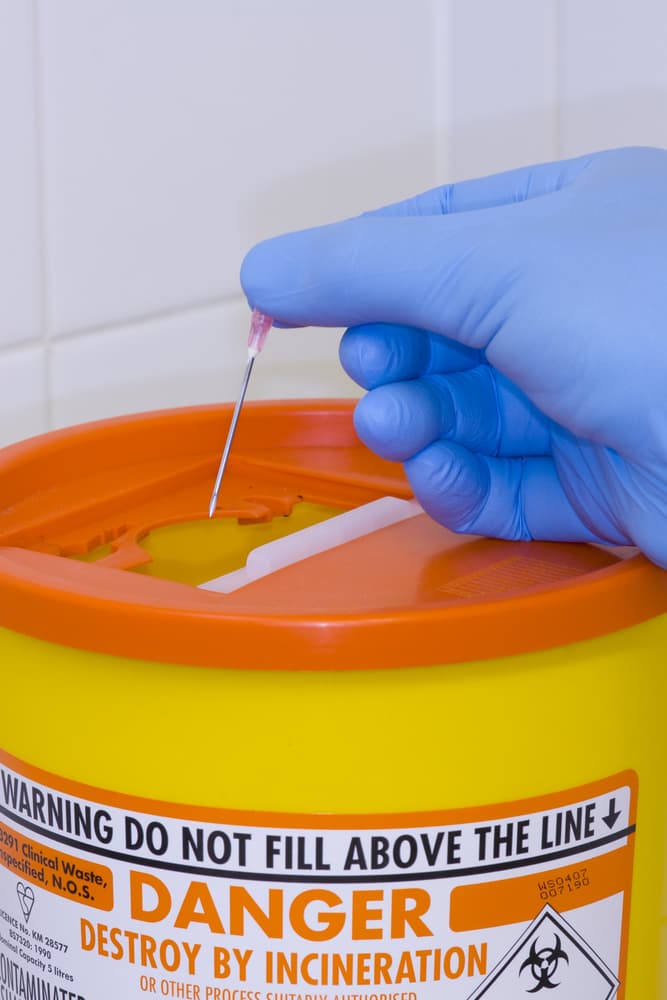In tour in diverse città italiane per approfondire temi legati alla diagnosi e alla terapia delle otiti esterne nel cane e nel gatto: è Ototour1, evento che nella sua seconda tappa ha toccato Modena. I colleghi Fabiano Necci (DMV, libero professionista) e Luca Luciani (DMV, master di II livello in dermatologia veterinaria) hanno presentato ai colleghi un approfondimento sull’importanza dell’esame citologico e sul ruolo del biofilm in queste affezioni.
L’esame citologico nelle otiti esterne
Dopo un richiamo sull’anatomia del condotto uditivo esterno e i criteri di classificazione delle otiti acute e croniche, i relatori hanno illustrato l’iter diagnostico da loro utilizzato per approcciare l’otite esterna.
Si parte da un’anamnesi approfondita, un EOG ed un EOP dei padiglioni auricolari e dei condotti uditivi, per valutare eventuale presenza di prurito, dolore e mineralizzazione.

Un passaggio fondamentale nella scelta della gestione terapeutica dell’otite esterna è l’esame citologico, che consente di identificare le popolazioni microbiche coinvolte e successivamente scegliere la molecola o le molecole da utilizzare nella terapia.
Sono stati poi descritti gli scenari citologici osservabili, dal più semplice al più complesso, descrivendo ed analizzando le differenze citologiche che consentono di distinguere le varie forme di otite esterna:
- eritematosa/ceruminosa non complicata: in cui si apprezza la presenza di materiale ceruminoso associato a corneociti;
- forme da sovracrescita: in queste forme si apprezza la presenza di lieviti o batteri in assenza di cellule infiammatorie;
- forme purulente: in cui si riscontra la presenza di cellule infiammatorie.
L’esame citologico è inoltre fondamentale oltre che per il monitoraggio della patologia soprattutto per decidere la sospensione della terapia, che potrà avvenire solo dopo ottenimento della negatività citologica.

Biofilm: perché non va sottovalutato
Il dott. Luciani ha poi affrontato le caratteristiche e le problematiche legate alla produzione di biofilm da parte dei microrganismi, e quindi quando eseguire e come interpretare l’esame colturale.
Il biofilm è un nemico estremamente pericoloso da non sottovalutare. Si tratta di un aggregato di microrganismi, solitamente batteri, che aderisce a una superficie organica e produce una matrice gelatinosa che prende il nome di glicocalice o EPS (Extracellular PolySaccarides). È considerato indice di infezioni croniche, ma si può trovare anche in alcune patologie acute (come la dermatite acuta umida): in vitro infatti è stato dimostrato che i batteri sono in grado di produrlo anche in 24 ore.
Inizialmente il biofilm viene prodotto da una singola specie microbica, ma nel tempo possono entrarne a far parte altri microrganismi, complicando l’approccio terapeutico. Una volta entrato a far parte della popolazione del biofilm, ogni microrganismo tende ad assumere caratteristiche genotipiche e fenotipiche differenti rispetto alla corrispettiva forma planctonica, spesso acquisendo caratteristiche di maggior resistenza.
Il biofilm può poi crescere, e parte dei microrganismi che lo costituiscono possono liberarsi colonizzando altre sedi, portando con sé tutte le nuove caratteristiche di resistenza acquisite, disseminando così l’infezione in altri siti, complicando ulteriormente il quadro clinico. Macroscopicamente appare come un materiale bruno- nerastro, a volte verdognolo, colloso e viscoso; microscopicamente si presenta come una sorta di pizzo, basofilo, a volte debolmente eosinofilo, più o meno spesso e denso, con imbrigliati al suo interno cellule e batteri.
Il biofilm è considerato pericoloso per via delle sue caratteristiche:
- l’EPS, o glicocalice, che ne costituisce l’85%, regola ciò che può entrare e uscire; mette in comunicazione i microrganismi che costituiscono il biofilm; neutralizza molecole potenzialmente pericolose che cercano di attraversarlo, inclusi gli antibiotici la cui concentrazione tende a ridursi nelle aree più profonde del biofilm;
- la presenza di cellule slow growing (precursori delle cellule persisters, con attività metaboliche diminuite) fornisce ai batteri un’ulteriore resistenza a fattori stressanti;
- il fenotipo biofilm-specifico induce modificazioni genetiche e fenotipiche delle cellule batteriche al suo interno e porta a un aumento della loro resistenza;
- i geni che codificano per le pompe di efflusso vengono attivati per la presenza di dosi subterapeutiche di antibiotico che non eliminano il batterio ma ne inducono una reazione (l’attivazione di maggiori pompe di efflusso, appunto), che permettono alle cellule di liberarsi di sostanze tossiche. Di conseguenza gli antibiotici che riusciranno a penetrare il glicocalice troveranno batteri in grado di proteggersi dal loro attacco in maniera più efficace;
- le cellule persisters (cellule metabolicamente inattive e quindi insensibili all’azione degli antibiotici) normalmente presenti in una quota fissa, possono aumentare in concomitanza di eventi stressanti. Esse fungono da ultimo baluardo di resistenza perché sono in grado di riattivarsi quando la fase stressogena diminuisce e così riportare in vita la popolazione del biofilm.
Presentando un suo studio di comparazione tra risultati microbiologici, citologici e di microscopia elettronica in corso di otiti batteriche nel cane, il relatore ha approfondito l’impatto dell’antibiotico sul biofilm in vitro, arrivando alla conclusione che gli antibiotici, alle concentrazioni abituali, riescono generalmente ad essere efficaci sul biofilm in costruzione ma non sempre quando è già costituito.
Nello studio, alcuni biofilm prodotti da ceppi di Staphilococcus pseudointermedius e Pseudomonas sono risultati resistenti a dosi di antibiotici presenti nei prodotti in commercio sottoforma di gocce otologiche. Trattandosi di uno studio in vitro, con condizioni ottimali per l’attività degli antibiotici, il relatore ha concluso che in vivo, dove le condizioni sono più complesse (cerume, pus, difficoltà di distribuzione omogenea), la situazione può solo peggiorare; tuttavia, per gli altri ceppi dove l’antibiotico a certe concentrazioni ha eradicato il biofilm, anche in vivo il farmaco potrebbe riuscire ad espletare la sua efficacia.
La presenza di biofilm si deve sospettare ogni volta che è osservabile sia macroscopicamente sia citologicamente; sempre di fronte a una problematica cronica e infine in tutte le otiti non responsive ai trattamenti standard e in cui non ci sia una patologia primaria sottostante non trattata o non considerata.
L’utilizzo dell’esame colturale
L’utilità di eseguire un esame colturale, come descritto dal relatore, è da valutare caso per caso.
- È sicuramente consigliato eseguirlo in caso di patologie croniche, perché è più probabile che si siano sviluppate resistenze agli antibiotici; in presenza di bastoncelli all’esame citologico; quando si è di fronte a un’otite purulenta oppure quando sono presenti ulcerazioni del condotto uditivo.
- È importante anche in pazienti in cui sono già stati riscontrati batteri resistenti, perché nel corso del tempo la situazione potrebbe essere peggiorata, oppure in soggetti non responsivi a una precedente terapia effettuata correttamente, avendo già escluso la problematica del biofilm.
- In corso di miringotomia (con campionamento di materiale dalla bolla timpanica) oppure sulla bolla timpanica (TECA-LBO), per scegliere l’antibiotico da somministrare per via sistemica.
- L’esame colturale non serve invece per confermare o meno un’infezione: in questo caso fa da guida l’esame citologico.
- Non serve per valutare l’efficacia o l’inefficacia in termini assoluti degli antibiotici, ma piuttosto per capire se il germe isolato presenti resistenze intrinseche a determinate classi di antibiotici.
- Non serve per evitare di seguire un iter diagnostico corretto (ad es. ricorso a TC).
I risultati di un antibiogramma devono essere interpretati in base all’anamnesi e al quadro clinico del paziente; essi devono essere correlati alla citologia e bisogna prestare attenzione alle eventuali incongruenze fra citologia ed esami colturali.
È importante inoltre fornire al laboratorio referente informazioni più complete possibili, per scegliere l’antibiotico da utilizzare, seguendo le linee guida EMA per indirizzarsi verso la molecola meno impattante per la situazione clinica dell’animale.
La terapia medica delle otiti esterne acute e croniche
L’obiettivo della terapia medica, in caso di otite esterne, è quello di eradicare l’infezione ed evitare lo sviluppo di resistenze nei microrganismi.
Nella pratica clinica tra le terapie abbiamo a disposizione antibatterici non antibiotici topici (es. clorexidina, tris-EDTA +/- N-acetilcisteina e peptidi antimicrobici), antibiotici topici e antibiotici sistemici (normalmente sconsigliati per la gestione dell’otite esterna).

Ruolo altrettanto importante nella terapia medica delle otiti risulta la gestione del dolore, fondamentale per aumentare la compliance del paziente nei confronti delle terapie topiche. Tra i farmaci frequentemente utilizzati abbiamo: corticosteroidi, gabapentin, meno frequentemente FANS.
Sono stati discussi alcuni scenari clinico-citologici per la gestione della pratica clinica delle otiti:
- per le otiti eritematoso/ceruminose (paziente affetto da dermatite atopica) con l’utilizzo in combinata di un ceruminolitico (es. squalene) più o meno associato a un corticosteroide topico (es. idrocortisone);
- per le otiti da sovracrescita (batterica, micotica o mista) con l’utilizzo di una terapia antibatterica non antibiotica in associazione a corticosteroide topico oppure sistemico, in base alla valutazione endoscopica del canale auricolare;
- per le otiti purulente, anche in presenza di biofilm, con l’utilizzo di un antibatterico non antibiotico topico a base di Tris-EDTA e N-acetilcisteina (Tris-NAC®) in associazione a un antibiotico topico e un corticosteroide topico oppure sistemico, da valutare in base alla situazione dell’animale. Il controllo del dolore è fondamentale, per aumentare la compliance del paziente nei confronti delle varie terapie topiche, in alcuni casi quindi si inizia prima con il corticosteroide sistemico e poi con le terapie locali.
- Per le otiti esterne croniche l’approccio terapeutico prevede sempre steroidi sistemici per controllare il dolore e ridurre l’infiammazione cronica, soluzioni con tris EDTA/N-acetilcisteina/peptidi per la disgregazione del biofilm.
- Per le otiti croniche eritematose/ceruminose si utilizza un ceruminolitico, una soluzione per disgregare il biofilm e, se necessario, un antibatterico non antibiotico topico in associazione a un corticosteroide sistemico. Può essere necessario ricorre a una video- otoendoscopia (VOE).
- Per le otiti croniche purulente si esegue una VOE per aspirare il materiale presente e pulire il condotto uditivo. Essendo una condizione purulenta, si applica un antibiotico trifasico, l’antimicrobico non antibiotico non è indicato in questo caso, sicuramente si associa il Tris NAC® per trattare il biofilm a un corticosteroide sistemico. In presenza di ulcere si può valutare il ricorso a un antibiotico sistemico, supportato però da un esame citologico ed un esame colturale.
- Per le otiti croniche iperplastiche/stenosanti si esegue una VOE e si interviene con il laser a diodi per rimuovere l’iperplasia quando possibile. La terapia medica si basa sul risultato dell’esame citologico; va sempre associato un cortisonico topico, una soluzione per disgregare il biofilm e un cortisonico sistemico.
- Per le otiti croniche associate a otite media/PSOM (Primary Secretory Otitis Media) si esegue una VOE e una miringotomia. La terapia medica si basa sul risultato dell’esame citologico e sull’esame colturale; va sempre associato un corticosteroide sistemico e un antibiotico o antimicotico sistemico in relazione agli esiti dell’esame colturale esguito dal materiale prelevato dalla bolla timpanica. Di fronte alle otiti croniche è sempre bene ricorrere alla diagnostica per immagini (TC): si stima infatti che dal 30% all’80% di cani con questa patologia sviluppi anche otite media.
I follow up sono essenziali, sia per l’otite acuta che cronica: queste patologie richiedono controlli seriali per poter modulare correttamente la terapia, che, per le otiti croniche, può durare diverse settimane.
Dopo la risoluzione si prosegue con una terapia a base di corticosteroidi topici e con antibatterici non antibiotici topici oppure una soluzione per disgregare il biofilm, a seconda della necessità. La cronicizzazione delle otiti esterne aumenta la necessità di farmaci sia in termini di tipologie, sia di quantità, aumenta il rischio di produzione di biofilm e antibioticoresistenza. Può anche aumentare il rischio di otiti medie e le mineralizzazioni dei condotti, così come il ricorso a terapie di mantenimento a vita oppure alla terapia chirurgica (es.TECA-LBO): l’obiettivo quindi è cercare di evitare la cronicizzazione di queste patologie.
- Modena, 30/3/2025: Navigando nel mondo delle otiti: tricks and tips per mantenere la rotta. Organizzato da ICF pet, in collaborazione con l’Associazione veterinari modenesi. ↩︎