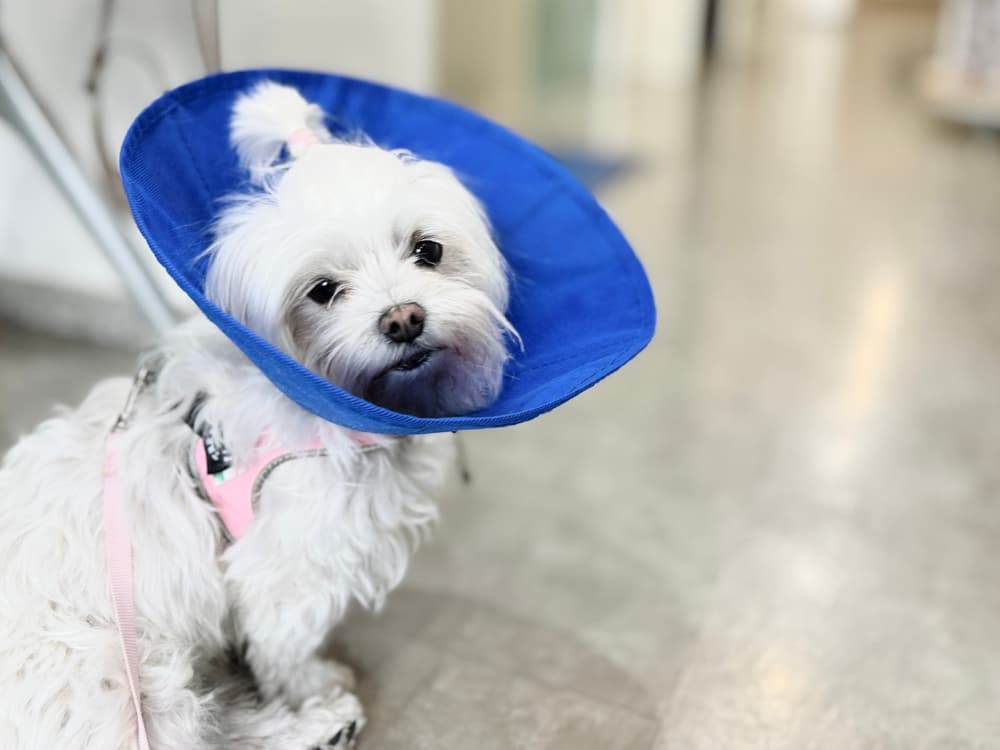Fino a non molti anni fa, la sterilizzazione chirurgica degli animali da compagnia era una pratica di routine, che veniva suggerita e presentata a tutti i proprietari di cani e gatti come strategia efficace per la prevenzione e/o il trattamento di alcune patologie (comportamentali e non). Si credeva infatti che i rischi associati all’intervento chirurgico fossero minimi in confronto ai benefici della procedura.
La recente pubblicazione delle linee guida WSAVA per il controllo della riproduzione di cani e gatti1 e nuovi studi di fisiopatologia hanno messo in discussione questa certezza, esortando i medici veterinari non solo a tenere in considerazione i possibili effetti avversi legati alla gonadectomia su medio e lungo periodo, ma anche a informare in modo più preciso e accurato il proprietario su tutti i rischi legati all’intervento e, in particolare, all’asportazione delle gonadi.
Proprio questo aspetto e stato il tema centrale del webinar promosso da Virbac in collaborazione con La Settimana Veterinaria, che ha avuto come relatrice la dott.ssa Maria Carmela Pisu (DVM, Dipl. ECAR)2.
Sterilizzazione nella femmina: da cosa protegge?
La relatrice ha esordito specificando che il corretto approccio alla sterilizzazione di cagne e gatte indicato dalle linee guida WSAVA indica che se non vi sono patologie uterine concomitanti va eseguita la sola ovariectomia; l’ovarioisterectomia deve infatti essere riservata alle situazioni in cui l’utero è compromesso.

Successivamente, la dott.ssa Pisu ha passato in rassegna le situazioni per le quali, nella femmina, la sterilizzazione sembrerebbe esercitare un effetto preventivo, soppesando i pro e i contro alla luce delle più recenti evidenze scientifiche in Medicina Veterinaria.
- La protezione dallo sviluppo dei tumori uterini e ovarici è indubbia se si attua un’asportazione di questi organi, ma è necessario valutare che la maggior parte delle neoplasie ovariche canine è di natura benigna e con incidenze trascurabili (circa ≤0,5%).
- L’iperplasia e il prolasso vaginale secondario sono sotto controllo estrogenico, in questo caso quindi la sterilizzazione esplica un effetto preventivo.
- La prevenzione dei calori – che possono creare difficoltà di gestione dell’animale ad alcuni proprietari – di gravidanze indesiderate e del randagismo sono ulteriori indicazioni a favore della sterilizzazione.
- Per le cagne che hanno sviluppato diabete diestrale e ricevono per questo un trattamento, la sterilizzazione è mandatoria.
- Per la piometra, invece, l’intervento di sterilizzazione un tempo era spesso attuato a scopo preventivo, oggi però questa patologia è gestibile anche con una terapia medica; inoltre, vi è da considerare che la decisione di sottoporre il paziente a un intervento chirurgico nell’ottica di prevenire l’eventuale necessità di effettuarne un altro, è discutibile.
- Riguardo ai tumori mammari vi è una convinzione, abbastanza radicata, che la sterilizzazione li prevenga. Questa idea si basa su un paper pubblicato più di 30 anni fa, quindi ormai datato, che evidenziava come l’ovariectomia, se effettuata prima del primo calore, ne riducesse l’incidenza allo 0,5%; prima del secondo calore all’8%; prima del terzo a meno del 26%. La relatrice ha sottolineato che una recente review3, che ha analizzato circa 11.100 studi sull’argomento, non è riuscita a giungere a tale conclusione definitiva, evidenziando la presenza di bias di varia natura e consistenza in quasi tutte le pubblicazioni. Inoltre, con il progredire delle conoscenze sulla patofisiologia dell’apparato riproduttore è stato chiarito che la sterilizzazione è preventiva per i tumori che esprimono i recettori per gli estrogeni (ER+), ma non per gli altri (ER-), che anzi sembrano essere più aggressivi nei soggetti sterilizzati.
- Infine, per quanto riguarda i carcinomi mammari, la sterilizzazione non ha alcun effetto sulla prevenzione delle forme geneticamente codificate (ad esempio, BRCA1 e BRCA2), in questi casi solo una mastectomia radicale preventiva potrebbe ragionevolmente abbattere il rischio, ma non annullarlo, poiché spesso un residuo di tessuto (dal 2 al 5%) permane in sede.
Sterilizzazione nel maschio: da cosa protegge?
Nel maschio, la castrazione ha azione indubbiamente preventiva per tumori e patologie testicolari, poiché questa ghiandola è sotto controllo del testosterone. Anche per l’iperplasia prostatica la castrazione può avere un effetto benefico, ma è opportuno tenere presente che oggi esistono terapie farmacologiche che permettono di gestire la patologia e i sintomi a essa associati. Nei soggetti castrati anche il prolasso uretrale, che si verifica con maggior frequenza nei simil molossoidi e molossoidi giovani ipereccitabili, sembra avere incidenza molto bassa.

Per la prevenzione dell’aggressività invece la castrazione agisce solo su quella testosterone-dipendente, che si manifesta in presenza di un conspecifico maschio e di una femmina disponibile all’accoppiamento. È possibile che la castrazione abbia un effetto benefico sull’ipersessualità e sull’autoerotismo continuo, queste alterazioni però possono essere gestite efficacemente anche con un approccio di tipo comportamentale.
I potenziali rischi
Se dunque alcuni vantaggi della sterilizzazione permangono, seppur ridimensionati nella loro importanza, recenti studi ne hanno invece evidenziato i possibili rischi. Da anni, infatti, negli Stati Uniti, dove la sterilizzazione chirurgica viene attuata precocemente e sulla quasi totalità degli animali da compagnia, è stata riscontrata una maggior prevalenza di alcune patologie metaboliche e di tumori nei pet sterilizzati rispetto all’Europa (soprattutto Svezia, Norvegia e Finlandia, dove invece la gonadectomia è effettuata quasi esclusivamente a scopo terapeutico). Tali rilievi rappresentano un punto di partenza per indagini future sul tema e spingono a riflessioni sul legame tra prevenzione, controllo della riproduzione e benessere animale.
Il ruolo dell’LH
A partire dall’età puberale, l’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi si attiva attraverso una cascata di ormoni che viene regolata con un sistema di feedback negativo. L’ipotalamo secerne GnRH, che a sua volta stimola l’ipofisi a produrre FSH e LH, responsabili dell’avvio dell’attività gonadica. Gli ormoni sessuali prodotti da ovaie o testicoli fungono da feedback per l’ipotalamo: la loro presenza viene rilevata e utilizzata come indicatore per regolare la secrezione di GnRH.
Negli animali sterilizzati, probabilmente a causa della mancanza di questo feedback gonadico, è stato rilevato un aumento della concentrazione circolante di FSH e LH. Negli animali sterilizzati sono state riscontrate maggiori concentrazioni circolanti di LH, e recenti ricerche hanno identificato la presenza di recettori per l’LH in vari distretti: nel tessuto cutaneo e linfatico, nell’endotelio dei vasi, nella corticale del surrene, nei legamenti e nella capsula articolare, nella prostata e nello sfintere uretrale e infine nell’epitelio di transizione della vescica.
Un livello di LH costantemente elevato può attivare (tanto in vitro quanto in vivo) questi recettori, determinando alterazioni del tessuto, spesso in senso neoplastico. Questo dato è in linea con quanto comunemente riscontrato nei furetti maschi che, una volta castrati, manifestano iperadrenocorticismo e adenocarcinomi surrenalici, che richiedono interventi d’urgenza.
Con l’impiego della deslorelina, agonista del GnRH che agisce sopprimendo la produzione di LH, non si osserva sviluppo di tali patologie, per la mancata attivazione dei recettori surrenalici da parte dell’LH.
LH e neoplasie
La presenza di recettori per l’LH su cellule immunitarie (ad esempio mastociti) ha indotto a indagare un possibile collegamento tra questi e l’insorgenza di mastocitoma, uno dei tumori cutanei più frequenti nel cane. I recettori per l’LH non solo sono overespressi nei mastocitomi, ma esistono tre pattern differenti di recettori: nell’ 86% delle mast cell dei cani castrati è presente un’overespressione soprattutto del pattern di tipo 2.
Anche nel linfoma, che rappresenta oltre il 23% di tutte le neoplasie canine, i recettori per l’LH risultano maggiormente overespressi nei linfociti T dei soggetti castrati (16,6%) rispetto agli interi (10,5%). In particolare, nei Golden retriever maschi è stato rilevato che la castrazione aumenta di tre volte il rischio di sviluppare linfomi. Nei linfociti B invece non si riscontrano differenze di espressione. Studi in vitro hanno confermato che la stimolazione dei recettori dell’LH nei linfomi promuove la replicazione cellulare.
L’emangiosarcoma è un’altra neoplasia aggressiva tipica del cane e riscontrabile, sebbene con percentuali decisamente più basse, anche nell’uomo (soprattutto ragazzi). L’aspettativa di vita media dalla diagnosi è pari a circa 86 giorni e aumenta fino a 190 giorni con opportune chemioterapie. Studi recenti hanno confermato nella muscolatura liscia dei vasi e nell’endotelio la presenza di recettori per l’LH attivi e attivabili nel momento in cui aumenta costantemente la concentrazione circolante di questo ormone.
Si stima che Boxer, Pastore tedesco e Rottweiler femmine sterilizzate presentino un rischio di sviluppare emangiosarcoma splenico pari al doppio, e pari a 5 volte per quello cardiaco. Il rischio è aumentato anche nel maschio, ma non e stata stimata precisamente l’entità di tale incremento.
Anche il carcinoma prostatico e correlato a elevati livelli di LH circolante. Si pensava che l’effetto della castrazione sullo sviluppo di questa neoplasia fosse imputabile alla mancata capacita di eiaculazione, che avrebbe un effetto protettivo sulle alterazioni prostatiche; in realtà, i recettori per l’LH nella prostata dei castrati sono molto più abbondanti e in questi soggetti il rischio aumenta di otto volte.
A differenza di quanto accade nell’uomo, nel cane questa tipologia di tumore non è testosterone dipendente. L’aspettativa media di vita dalla diagnosi e pari a circa 9 settimane. L’intervento di prostatectomia per rimuovere la massa e associato a elevata morbilità e grande discomfort per il paziente, e a un incremento poco incisivo dell’aspettativa di vita (2 settimane).
Altra grave neoplasia è il carcinoma delle cellule di transizione che può colpire vescica, uretra e ureteri. La sopravvivenza media a 12 mesi dalla diagnosi e inferiore al 20% anche in presenza dell’opzione terapeutica migliore. Nelle cellule di transizione dei soggetti gonadectomizzati sono stati rilevati recettori LH overespressi e attivabili che comportano un aumento significativo del rischio di sviluppare questa neoplasia.
Tra i tumori ossei, l’osteosarcoma è tra i più aggressivi con basso tasso di guarigione, anche con il migliore approccio terapeutico. Si è visto che il rischio di sviluppare questa neoplasia è doppio nei Rottweiler castrati, mentre nel Pastore tedesco non è statisticamente significativo. Sono stati riscontrati recettori dell’LH a livello legamentoso e nel periostio, ma non vi e conferma della loro presenza nelle cellule ossee; recenti studi stanno quindi indagando su quanto la presenza di questi recettori nei tessuti limitrofi e strettamente connessi influisca sull’aumento di rischio di sviluppo dell’osteosarcoma.
LH e dismetabolie
L’aumento costante dell’LH circolante sembra essere correlato quindi all’aumento del rischio di sviluppo di neoplasie e alcuni studi lo indicano anche come fattore promuovente alcuni dismetabolismi. In Medicina Umana e noto che le donne sottoposte a ovariectomia presentano un rischio di ipotiroidismo raddoppiato, e nelle pazienti affette e stata riscontrata la presenza di recettori per l’LH a livello tiroideo.
In Medicina Veterinaria, recenti studi hanno permesso di affermare che vi e una co-localizzazione dei recettori per LH e TSH e che quindi un aumento di occupazione recettoriale da parte dell’LH avverrebbe a discapito del TSH. Il rischio di sviluppare ipotiroidismo, similmente a quanto avviene nella donna, è quindi aumentato nelle cagne sterilizzate ( ≥30%).
Nei cani castrati, indipendentemente dal controllo del peso e dalla dieta, è stata registrata un’incidenza di diabete mellito doppia rispetto ai soggetti interi, e nei primi vi è overespressione pancreatica dei recettori per LH.
Sterilizzazione e incontinenza urinaria
L’incontinenza urinaria è un’altra problematica dei soggetti sterilizzati, sicuramente meno grave dal punto di vista della sopravvivenza, ma comunque molto importante per l’animale e per la sua gestione da parte del proprietario. Si stima che siano a rischio di questo effetto collaterale circa il 5-30% dei cani sterilizzati, soprattutto se l’intervento e eseguito in età prepubere. Altri fattori che sembrano correlati alla sua insorgenza sono la taglia sopra i 20 kg e la razza (ad esempio, Boxer, Pastore tedesco, Golden retriver).
Il fattore principale è il calo degli estrogeni, i quali oltre ad assicurare il trofismo dello sfintere, attivano i recettori α2 adrenergici, utili per ottenere una contrazione efficace. Tuttavia, solamente il 55% delle cagne a cui vengono somministrati estrogeni torna perfettamente continente (dato analogo a quanto osservato nelle donne, 45%).
Anche a livello di sfintere e collo uretrale sono presenti recettori per l’LH, e a questo ormone si imputa circa il 40% della responsabilità dell’incontinenza. Questo dato è in linea con l’aumento della percentuale di cagne che ritornano continenti dopo somministrazione di deslorelina in combinazione con estriolo o da sola, poiché grazie alla sua azione agonista del GnRh, agisce sopprimendo la produzione di LH e quindi l’azione di questo ormone sullo sfintere, e promuove il ripristino della continenza.
Altri effetti
Il benessere fisico e psicologico del paziente deve essere un altro driver di scelta. Gli ormoni sessuali nel cane, similmente all’uomo, sembrano esercitare effetti benefici sul comportamento e sul tono dell’umore. Inoltre, il progesterone e gli estrogeni agiscono sui recettori GABAergici a livello neuronale, e l’effetto eccitatorio è disinibente attraverso la loro soppressione conseguente all’ovaristerectomia, può talora alterare l’autocontrollo e sfociare in un aumento dell’aggressività in soggetti già neofobici.
Similmente agisce il testosterone, che in condizioni normali riduce le manifestazioni ansiose e di paura aumentando la resilienza: privando un soggetto di questo ormone, potrebbero scatenarsi reazioni di aggressività da paura e autodifesa. Esso inoltre agisce sul comportamento sociale ed esercita un ruolo fondamentale nell’equilibrio comportamentale, modulando l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene con meccanismo di down regolazione.
Secondo studi di Medicina Umana, inoltre, agli estrogeni viene attribuito anche un effetto benefico sull’apprendimento e sul tono dell’umore: la sterilizzazione potrebbe quindi favorire l’insorgenza di demenza senile e sconvolgere l’equilibrio psichico. I In caso di alterazioni comportamentali, dunque, la sterilizzazione andrebbe presa in considerazione solo in seconda battuta, dopo un consulto con un comportamentalista.
A livello legamentoso, nei cani sterilizzati e stata riscontrata overespressione dei recettori dell’LH, e un aumento del rischio di rottura del crociato pari a 5 volte nelle femmine e a quasi 5 volte nel maschio. Indipendentemente dall’eventuale aumento di peso in seguito a castrazione, si è visto un raddoppio del rischio di displasia d’anca, che però non è stato dimostrato nella femmina sterilizzata. Sono stati individuati recettori per LH attivabili nel legamento della testa del femore.
Alla luce di tutti questi dati, già nel 2020 alcuni ricercatori hanno indagato per identificare a quale età la sterilizzazione impattasse meno sul rischio di sviluppo di alterazioni metaboliche e neoplastiche, evidenziando tuttavia età ben oltre il periodo soglia indicato per la prevenzione del tumore mammario.4,5
La sterilizzazione: una valutazione caso per caso
La relatrice ha concluso sottolineando come, in ogni caso, tutte le considerazioni fin qui espresse devono essere valutate per ogni singola situazione, analizzando attentamente le caratteristiche del proprietario, del paziente e dell’ambiente in cui vive. Solo un’attenta analisi dei pro e contro della sterilizzazione può aiutare a scegliere l’opzione migliore.
Il proprietario deve essere coinvolto a 360° in questo processo: solo un’adeguata informazione su rischi e benefici può condurre a una scelta consapevole e ridurre eventuali reclami, qualora subentrassero effetti collaterali.
Andrà spiegato anche che i soggetti interi devono essere sottoposti a screening con maggior frequenza rispetto agli sterilizzati: con controllo delle mammelle a ogni vaccinazione; un’ecografia ginecologica dopo ogni calore dall’età di tre/quattro anni, ecc.

Se dopo la valutazione si definisce che e necessario od opportuno sterilizzare un soggetto, bisogna considerare anche alcune opzioni alternative a quelle “più tradizionali”: eseguire la vasectomia oppure un impianto di deslorelina, che potrebbe ovviare a determinati aumenti di rischio. Secondo alcuni recenti studi, un’opzione è anche quella di lasciare in sede le ovaie e attuare un’isterectomia totale da tuba a cervice.
Oggi, quindi, l’approccio alla sterilizzazione deve cambiare: il medico veterinario è chiamato a valutare i propri pazienti caso per caso, a informare tutti i proprietari e a proporre alternative meno invasive rispetto alla tradizionale gonadectomia.
- Romagnoli S, Krekeler N, de Cramer K, Kutzler M, McCarthy R, Schaefer-Somi S. WSAVA guidelines for the control of reproduction in dogs and cats. J Small Anim Pract. 2024; 65(7):424-559. doi: 10.1111/jsap.13724. Vedere a tal proposito: Sterilizzazione di cani e gatti: analisi delle raccomandazioni WSAVA ↩︎
- 21/1/2025: 2025… e la sterilizzazione? Organizzato da Virbac, in collaborazione con La Settimana Veterinaria. ↩︎
- Beauvais W, et al. The effect of neutering on the risk of mammary tumours in dogs–a systematic review. J Small Anim Pract. 2012;53(6):314-22. ↩︎
- Howe LM. Current perspectives on the optimal age to spay/castrate dogs and cats. Vet Med (Auckl). 2015;6:171-180 ↩︎
- Hart BL, et al. Assisting decision-making on age of neutering for 35 breeds of dogs: associated joint disorders, cancers, and urinary incontinence. Front Vet Sci. 2020;7:388. ↩︎