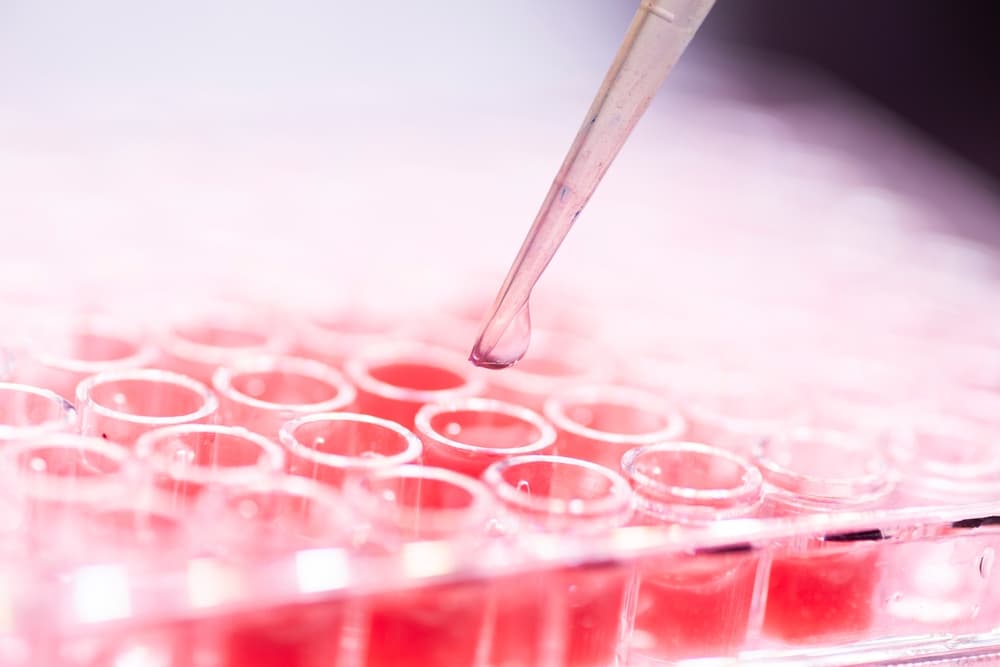Proseguono gli eventi online, organizzati da GISMVet (Gruppo Italiano Staminali Mesenchimali-Sezione Veterinaria) dedicati alle cellule mesenchimali stromali e alle terapie rigenerative in ambito veterinario. Il dott. Maurizio Del Bue (già professore ordinario di Clinica chirurgica veterinaria dell’Università degli Studi di Parma), ha coordinato il secondo incontro.1
Le cellule mesenchimali stromali: antinfiammatori “diversi”
La dott.ssa Ana Ivanovska (Università di Galway, Irlanda), ha esordito illustrando l’attività antinfiammatoria delle cellule mesenchimali stromali (MSC) e le loro interazioni con il sistema immunitario.
Come sappiamo, l’infiammazione è un meccanismo di difesa necessario per ripristinare l’omeostasi tissutale. Al danno tissutale, l’organismo reagisce con il reclutamento di cellule del sistema immunitario, che costituiscono la prima linea di difesa, e il rilascio di mediatori infiammatori. A ciò fa seguito l’attivazione delle cellule infiammatorie e il conseguente rilascio di citochine e fattori di crescita. Il processo continua con l’apoptosi delle cellule infiammatorie e la proliferazione delle cellule del tessuto danneggiato, concludendosi con il ripristino dell’architettura tessutale e la risoluzione dell’infiammazione.
Uno studio pubblicato su Nature2 ha posto in relazione le diverse fasi della guarigione tissutale (infiammatoria, riparativa e di rimodellamento), correlandole con l’efficacia terapeutica delle cellule mesenchimali. Nella prima fase, in cui si osserva il picco infiammatorio dovuto alla presenza di cellule del sistema immunitario con citochine, chemochine e mediatori dell’infiammazione, si ha la massima efficacia del trattamento con MSC.
L’attività immunomodulatoria delle MSC iniettate all’atto della terapia si estrinseca grazie ad alcune caratteristiche peculiari:
- le MSC possiedono la capacità innata di migrare (homing) verso il tessuto danneggiato. Queste cellule, infatti, possiedono sulla superficie particolari recettori in grado di captare le chemochine rilasciate dal tessuto infiammato. Seguendo la traccia di queste molecole, arrivano sul bersaglio;
- una volta arrivate, le MSC vengono attivate (licensing) e si comportano in modo simile ai leucociti: tramite un’azione di rotolamento, mediato da molecole di superficie, aderiscono all’endotelio, nel punto in cui il segnale dato da particolari mediatori, chiamati integrine, è più forte;
- attraversato l’endotelio, trasmigrano attraverso i vasi sanguigni, per arrivare infine al tessuto danneggiato; qui sono in grado di modulare l’infiammazione, in base ai segnali rilasciati dal tessuto stesso.
Le MSC contribuiscono in modo terapeutico alla guarigione fondamentalmente attraverso il loro secretoma, che contiene fattori di crescita e immunomodulatori. È importante sottolineare che l’attività immunomodulatoria può esercitarsi in due modalità: immunosoppressiva o immunostimolatoria. Questo comportamento differenzia l’attività delle MSC da quella dei normali farmaci antinfiammatori tradizionali, in quanto il comportamento delle MSC è plasmato dagli stimoli ricevuti nel tessuto danneggiato, che vengono captati attraverso i recettori di superficie (Toll Like Receptors, TLRs).
I TLR3 possiedono un basso livello di citochine pro-infiammatorie e determinano un’attività immunostimolante, mentre i TLR4 possiedono un alto livello di citochine e determinano attività immunosoppressiva.
I meccanismi immunomodulatori sono di due tipi: o tra cellula e cellula (più rari) oppure tramite produzione di fattori solubili, meccanismo più comune e più studiato dal momento che la misurazione in vitro di tali fattori può dare un’indicazione del loro effetto terapeutico.
Per comprendere tale processo è necessario conoscere il ruolo del sistema di difesa dell’organismo.
- Il sistema immunitario innato, che forma la prima linea di difesa, è caratterizzato da elementi cellulari quali macrofagi, granulociti neutrofili, cellule dendritiche, mastociti, etc, ed è attivato da antigeni tramite meccanismi di difesa non specifici. Le MSC possono interagire con il sistema innato tramite la secrezione di diversi fattori solubili. Tali fattori, possono, ad esempio, stimolare la polarizzazione verso i macrofagi di tipo M2 (ad azione antiinfiammatoria) a scapito dei macrofagi M1 (azione infiammatoria). La secrezione di IL6 può ridurre l’apoptosi dei neutrofili; la prostaglandina 2 può inibire il rilascio di istamina dai mastociti e entrambe possono modulare l’attività delle cellule dendritiche, favorendo quelle ad attività antinfiammatoria.

- Diverso è il sistema immunitario adattativo; costituito da cellule B, cellule T e anticorpi e attivato dal contatto con patogeni, esso agisce attraverso la memoria immunologica. L’effetto delle cellule MSC sul sistema immunitario adattativo si esplica attraverso diversi meccanismi:
- riduzione della proliferazione di cellule B e della formazione di anticorpi;
- riduzione delle cellule T e degli effetti di citotossicità e infi ammatori;
- azione sui linfociti T CD4+, che producono fattori antinfi ammatori.

In definitiva, le MSC esercitano un effetto duplice nella risoluzione dell’infiammazione:
- in una prima fase esercitano un’azione immunostimolante, con un benefico effetto dato dall’attivazione di neutrofi li e macrofagi M1;
- una volta raggiunto il picco dello stadio infiammatorio, le MSC possono produrre citochine con effetto antinfiammatorio, che agiscono stimolando la produzione di macrofagi di tipo M2 e cellule dendritiche tollerogeniche.
La plasticità immunologica aiuta a standardizzare le terapie cellulari e la collaborazione con i clinici, attraverso i prelievi di tessuti, liquido sinoviale ecc. può aiutare a comprendere quali tipi cellulari e mediatori siano presenti e sviluppare così terapie con MSC specifiche, sebbene in Medicina Veterinaria sussista un ulteriore grado di complessità, dovuto alle diverse specie, ognuna con mediatori differenti.
L’effetto terapeutico delle MSC viene influenzato dall’utilizzo di colture in vitro e dallo stato infiammatorio del tessuto lesionato. Sarebbe utile sviluppare trattamenti farmacologici mirati per determinati tipi di lesioni. Risulta importante anche sfruttare il priming, cioè l’efficacia in diversi stadi, che abbiamo visto essere più alta negli stadi iniziali dell’infiammazione.
Farmaci a base di cellule mesenchimali stromali disponibili sul mercato
Ad oggi sono stati approvati dall’EMA (European Medicine Agency) in Medicina Veterinaria quattro farmaci (tre per l’utilizzo nel cavallo e uno per i cani) e sono disponibili per l’utilizzo da parte dei medici veterinari. Target di tutti i farmaci solo le patologie muscolo scheletriche. Le vie di somministrazione sono intra-articolari o intra-tessutali, nel caso dei farmaci utilizzati sui cavalli. Tutti i farmaci prevedono un’unica somministrazione.
Le indicazioni sono varie, ma nel cavallo si concentrano sulle infiammazioni articolari non settiche che causano zoppie, sulle patologie osteoartritiche (specie delle falangi) e in quelle tendinee e legamentose (a livello falangeo). Nel caso del cane, il farmaco viene somministrato per via intrarticolare, ed è efficace nell’osteoartrite di gomito e anca. Come abbiamo già visto, gli effetti avversi sono principalmente locali, con tumefazione e zoppia, e possono essere mitigati con una contemporanea somministrazione di una dose di FANS, a discrezione del veterinario.
Aspetti normativi nelle terapie con cellule mesenchimali stromali
La dott.ssa Silvia Dotti (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia- Romagna) ha illustrato la normativa concernente l’utilizzo delle terapie a base di MSC. L’Istituto Superiore di Sanità fornisce una definizione di medicina rigenerativa come quella nuova frontiera della medicina che si “occupa di riparare, rigenerare o sostituire tessuti o organi danneggiati da malattie, traumi o a causa di effetti presenti alla nascita (congeniti), o di invecchiamento”.

In base ai diversi tipi di approcci, la medicina rigenerativa viene valutata in base ai componenti di base, oppure al loro utilizzo. Da questi due ambiti deriva la normativa di riferimento:
- Decreto 2 novembre 2015 (“Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”) per quanto riguarda le MSC come emocomponente (origine ematica);
- Reg. UE 2019/6 (che stabilisce norme “in materia di immissione sul mercato, fabbricazione, importazione, esportazione, fornitura, distribuzione, farmacovigilanza, controllo e impiego dei medicinali veterinari”) per quanto riguarda le MSC come prodotti contenenti o costituiti da cellule (origine cellulare);
- Decreto 12 novembre 2011 (relativo alle Buone pratiche di sperimentazione clinica dei medicinali veterinari sugli animali) e Linee guida 26 novembre 2013 (“concernenti i requisiti sanitari minimi per l’impiego delle cellule staminali in Medicina Veterinaria”) per quanto riguarda l’utilizzo delle MSC autologo o allogenico;
- Linee guida 26 novembre 2013 e Reg. UE 2019/6 riguardo all’utilizzo delle MSC in farmaceutica e nelle piccole produzioni.
A seconda dei campi di applicazione, la medicina rigenerativa può essere suddivisa in:
- ingegneria dei tessuti;
- terapia cellulare e genica;
- dispositivi medici;
- organi artificiali.
Gli emocomponenti per uso non trasfusionale possono essere manipolati per ottenere i prodotti biologici con diverse caratteristiche. In Italia è però autorizzata solo la terapia cellulare autologa; l’utilizzo allogenico è consentito solo in alcuni campi di ricerca.
L’utilizzo dei prodotti di terapia avanzata
Per valutare un potenziale utilizzo dei prodotti di terapia avanzata è necessario scegliere l’approccio più indicato per la terapia.
- Nell’approccio one step, ultimamente più usato, si utilizzano dispositivi medici che escludono il laboratorio, perché sono chiusi e l’unico attore è il veterinario. I dispositivi autorizzati non consentono manipolazioni e contaminazioni, in quanto la procedura di estrazione del tessuto adiposo e successivo inoculo delle cellule stesse, avviene direttamente in sala operatoria da parte del veterinario.
- Nell’approccio multi step laboratori e veterinari sono entrambi coinvolti. Il prelievo, infatti, viene effettuato dal veterinario e in seguito conferito al laboratorio che effettua le manipolazioni e lo riconsegna al medico. L’aumento del numero di passaggi aumenta il rischio di contaminazioni. In questo caso il laboratorio deve garantire standard di qualità rigorosi in relazione alle diverse fasi:
- prelievo;
- manipolazione;
- controllo del prodotto finito;
- conservazione del prodotto finito;
- distribuzione del prodotto finito.
- L’approccio bioingegneristico è per ora confinato alla parte di ricerca e coinvolge un’equipe con varie figure di ricercatori.
- 28/5/2024. Attività anti-infiammatoria delle MSC e loro interazioni con il sistema immunitario. I farmaci cellulari. Aspetti normativi. Webinar organizzato dal Gruppo Italiano Staminali Mesenchimali – Sezione Veterinaria (GISMVet, www.gismonline.it) con la collaborazione di Cogito Ergo Vet. ↩︎
- Wang Y, Chen X, Cao W, Shi Y. Plasticity of mesenchymal stem cells in immunomodulation: pathological and therapeutic implications. Nat Immunol. 2014;15(11):1009-16. doi: 10.1038/ni.3002. ↩︎