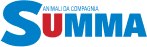I coronavirus sono noti da tempo in medicina veterinaria. Nei gatti è presente un coronavirus molto virulento, responsabile della peritonite infettiva felina (FIP). Questa malattia ha un tasso di mortalità prossimo al 100% e rappresenta quindi un notevole problema in medicina felina.
Coronavirus e FIP
Il coronavirus felino è un virus a RNA con envelope. Appartiene alla famiglia Coronaviridae e al genere Alphacoronavirus. La classificazione dei FCoV (feline coronavirus) è piuttosto complessa. In base alle loro proprietà antigeniche e genetiche, sono classificati nei sierotipi/genotipi 1 e 2. Il genotipo 1 (o clade A) è il più frequentemente isolato e la sua distribuzione è mondiale. Il genotipo 2 (o clade B) si trova principalmente in Asia. Quest’ultimo, molto più facile da coltivare in vitro rispetto al genotipo 1, viene quindi utilizzato principalmente in studi sperimentali.
I FCoV sono stati inoltre classificati in due biotipi, rinvenuti all’interno dei due genotipi sopra menzionati, in base all’espressione della loro patogenicità:
- Biotipo “non virulento”, o Coronavirus enterico felino (FeCV), generalmente responsabile di infezioni asintomatiche e, talvolta, di una lieve enterite transitoria
- Biotipo “virulento”, ovvero il virus responsabile della peritonite infettiva felina (FIPV)
A livello strutturale, non sussistono grandi differenze tra i due genotipi e i due biotipi. Tra le proteine strutturali del virione, una delle proteine dell’envelope, la proteina spike (o spike S), gioca un ruolo chiave nella fisiopatologia, in quanto è coinvolta nel legame del virus al suo recettore cellulare e costituisce un bersaglio della risposta immunitaria.
Come la maggior parte dei virus a RNA e nonostante l’esistenza di un meccanismo di correzione degli errori che si verificano durante la sintesi dell’RNA, i coronavirus hanno un’alta percentuale di mutazioni. È questo il meccanismo coinvolto, secondo vari autori, nei cambiamenti del tropismo (infezioni dei macrofagi) e nella patogenicità del FCoV, contribuendo alla comparsa e alla diffusione del FIPV e all’insorgenza della FIP.
All’interno delle popolazioni di coronavirus felini, sono state caratterizzate alcune mutazioni dei geni accessori di FCoV e del gene S. Pertanto, due mutazioni del gene S (M1058L o S1060A) sono state recentemente associate alla capacità di infettare i monociti e i macrofagi, fattore che viene considerato un marker di moltiplicazione sistemica di FCoV.
La dicotomia FeCV-FIPV è stata recentemente rivisitata con la dimostrazione di FCoV sistemici che non possono essere qualificati come enterici né come FIPV poiché non causano FIP, contribuendo così alla diversità dei FCoV e mettendo in discussione il concetto di FeCV-FIPV.

La plasticità genomica dei coronavirus non si limita all’accumulo di mutazioni, in quanto subiscono anche fenomeni di ricombinazione omologa e non omologa con una frequenze superiore a quelle osservate in tutti gli altri virus a RNA.
Questo aspetto è stato particolarmente studiato nei coronavirus dei carnivori domestici che, in questo modo e grazie alle trasmissioni interspecie, sono distribuiti nei due gruppi genetici descritti (tipo 1 e 2) e in continua evoluzione (dimostrazione di virus ricombinanti tra cladi).
È sulla base delle sequenze dei geni S che potrebbe essere analizzata l’evoluzione di queste popolazioni virali. I FCoV di tipo 1 esprimono la proteina S originale felina, mentre i FCoV di tipo 2 hanno acquisito un gene S (e spesso altri geni) dopo ricombinazione con l’alphacoronavirus canino (CCoV).
Epidemiologia
FCoV è estremamente contagioso. La trasmissione avviene per via oro-fecale, per contatto diretto, ma anche per contatto indiretto tramite lettiera. La trasmissione sembra iniziare molto presto, con la contaminazione dei gattini da parte delle madri escretrici, tra le 6 e le 10 settimane di età, quando gli anticorpi materni scompaiono.

Nelle comunità, la prevalenza varia dal 32 al 100%, a seconda degli studi. Un recente studio, condotto in Germania, ha dimostrato che FCoV era presente in 37 allevamenti testati. La maggior parte dei gatti (137 su 179) ha diffuso il virus almeno una volta durante lo studio. Questo studio ha anche dimostrato che la frequenza di pulizia o disinfezione delle lettiere non ha alcun impatto sull’escrezione. Allo stesso modo, non è stata dimostrata alcuna differenza nell’escrezione in base allo stile di vita (uscite vs solo ambiente domestico) e alla densità dei gatti per metro quadrato.
È comunque classicamente accettato che la densità di una popolazione, l’igiene dell’ambiente e lo stile di vita siano fattori di rischio per l’infezione. Studi longitudinali hanno rivelato che la diffusione del coronavirus felino può essere permanente o intermittente (70-80% dei gatti positivi a FCoV). Definire un gatto come “non escretore” di FCoV è quindi complicato. Questi dati dimostrano che, sul campo, è molto difficile risanare ed eliminare FCoV. Al contrario, la FIPV sembra essere poco contagiosa.
Patogenesi della FIP
L’ingresso del virus nelle cellule bersaglio avviene grazie alla proteina S. La subunità S1 consente il legame al recettore cellulare, e la subunità S2 la fusione dell’involucro virale e della membrana cellulare dopo l’attivazione di una proteasi virale.
FCoV-I e FCoV-II utilizzano probabilmente recettori cellulari diversi (30% di identità tra l’S1 dei due virus). Il recettore cellulare FCoV-I non è stato ancora identificato. Lo studio di questo genotipo più abbondante è complicato dal fatto che questo virus si replica difficilmente in vitro.
L’infezione da FeCV è spesso asintomatica o paucisintomatica ma, poiché il virus si replica negli enterociti, può indurre diarrea. Una risposta umorale è rilevabile 10 giorni dopo l’infezione primaria e gli anticorpi persistono per tutta la vita a bassi titoli. Si osserva una diversità nell’evoluzione dell’infezione, potendo i gatti eliminare il virus, essere escretori intermittenti o escretori permanenti (almeno diversi anni).
Solo dal 5 al 12% dei gatti infetti da FeCV sviluppa la FIP e i meccanismi di insorgenza della malattia non sono ancora del tutto chiariti. Come sopra indicato, è comunque accettato che la variabilità del virus favorisca la comparsa di mutazioni che gli consentono di modificare il tropismo cellulare e di esprimere nuovi fattori di virulenza. Pertanto, un’infezione attiva aumenta il rischio di comparsa di virus mutati in grado di infettare efficacemente monociti e macrofagi. FeCV diventa quindi sistemico ed evolve in FIPV.
Successivamente, il meccanismo associato alla comparsa di FIPV e quindi della FIP rimane sconosciuto. La FIP è considerata una malattia immunitaria, in quanto FIPV causa una grave deregolazione del sistema immunitario. L’attivazione incontrollata dei macrofagi è causata dall’infezione e dalla replicazione di FIPV, che si traduce in una maggiore espressione di molecole di adesione che facilitano la loro adesione alle cellule endoteliali e nella sintesi fuori controllo di citochine proinfiammatorie, come IL-1β, IL-6 e TNF-α.
Le diverse forme cliniche dipendono dalla natura della risposta immunitaria attivata. La FIP secca (o granulomatosa) è caratterizzata da una marcata risposta cellulare e ha un’evoluzione clinica più lenta. Al contrario, la FIP effusiva, con un’evoluzione clinica molto più rapida, è caratterizzata da una mancanza di risposta cellulare e da un’attivazione aberrante della risposta umorale.
Questa risposta umorale, poco efficace, è talvolta anche responsabile del fenomeno dell’antibody-dependent enhancement (ADE). Gli anticorpi, invece di svolgere un ruolo protettivo, contribuiscono alla più rapida diffusione del virus, in particolare facilitando l’infezione dei macrofagi.

È dimostrata, in alcuni gatti, un’evoluzione dalla forma secca alla forma effusiva, probabilmente legata a un collasso della risposta cellulare.
I fattori di rischio
Anche se i meccanismi fisiopatologici che spiegano i segni clinici della FIP sono meglio conosciuti, rimangono molti interrogativi sull’evoluzione verso la FIP solo per alcuni gatti FeCV-positivi. I fattori genetici giocano un ruolo chiave.
Diversi studi hanno infatti rivelato l’esistenza di un rischio legato alla razza, ma soprattutto al lignaggio o alla famiglia. Nonostante queste predisposizioni razziali o familiari, un ruolo degli alleli dei geni del complesso maggiore di istocompatibilità di classe II non è stato dimostrato in termini di suscettibilità alla FIP.
La seconda ipotesi considerata è quella del polimorfismo dei geni coinvolti nella risposta immunitaria cellulare. Lo studio del polimorfismo di questi geni fornisce risultati divergenti a seconda delle pubblicazioni. Un primo studio ha dimostrato un legame tra alcuni alleli dell’interferone gamma (IFNγ, citochina chiave della risposta cellulare) e il rischio di insorgenza di FIP nei gatti FeCV-positivi.
Più recentemente, uno studio condotto su 59 gatti Europei ha rivelato che le variazioni alleliche del gene che codifica per l’IFNγ contribuiscono alla resistenza o alla sensibilità felina.
Questi dati sono in contraddizione con uno studio condotto su 22 gatti di razza, che non ha mostrato un aumento del rischio in funzione delle mutazioni dei geni che codificano per le molecole coinvolte nella risposta Th1 (compreso l’IFNγ).
I geni coinvolti nella sensibilità alla FIP rimangono, a oggi, non identificati. Un recente studio, condotto su gatti di diverse origini, ha mostrato un’associazione tra un gene coinvolto nell’immunità innata, l’attivazione delle cellule NK e il livello di escrezione di FCoV. Tuttavia, più il virus si replica, maggiore è il rischio che compaiano mutazioni: questo potrebbe quindi essere un primo passo nel passaggio alla FIP.
Diagnosi
La diagnosi definitiva di FIP è una sfida per il medico veterinario. La tecnica di riferimento rimane infatti l’individuazione nei tessuti danneggiati degli antigeni di FCoV (quindi di FIPV) mediante immunoistochimica. Tuttavia, è necessario inviare biopsie di tessuti che presentano lesioni compatibili con la FIP. Questo test viene quindi spesso eseguito post mortem, perché eseguire biopsie adeguate è complicato e invasivo.
La diagnosi è complessa anche per la mancanza di un test per distinguere con certezza FeCV da FIPV (o gli anticorpi specifici per ciascun virus). Poiché FeCV è estremamente contagioso, la sieroprevalenza dei gatti FeCV+ è molto alta (dal 30 al 100%, a seconda degli studi) e poiché non esiste un test sierologico per differenziare un gatto FeCV+ da un gatto PIFV+, la rilevazione di anticorpi in caso di sospetto non ha nessun significato diagnostico. Un test negativo inoltre non esclude la FIP, poiché nel 10% dei gatti malati gli anticorpi non sono rilevabili.
È quindi necessario adottare un approccio diagnostico rigoroso per stabilire una diagnosi di certezza ante mortem.
La FIP si riscontra spesso nei gatti di età inferiore a 2 anni. Le manifestazioni cliniche sono molto diverse e talvolta poco aspecifiche. La diagnosi è più facile in caso di FIP effusiva, con la presenza di un versamento addominale o toracico. Come con la sierologia convenzionale, i test che rilevano gli anticorpi nel versamento hanno valori predittivi positivi e negativi troppo bassi e non dovrebbero essere utilizzati.

© sahlan – shutterstock.com
In caso di versamento è possibile utilizzare test per differenziare tra essudato e trasudato (test di Rivalta). Questi test hanno un buon valore predittivo negativo e un risultato negativo consente di escludere la FIP con un buon livello di confidenza. D’altra parte, se un test positivo conferma la natura infiammatoria del liquido di versamento, si deve tener presente che l’infiammazione può avere cause diverse dalla FIP (peritonite batterica, linfoma ecc.). Quando un test di Rivalta è positivo, la diagnosi dovrebbe quindi essere confermata.
La ricerca di antigeni virali mediante immunofluorescenza nel liquido dei versamenti ha una specificità molto buona, ma una sensibilità variabile a seconda degli studi. Non è quindi possibile interpretare un test negativo. È anche possibile utilizzare la tecnica della reazione a catena della polimerasi a trascrittasi inversa (test RT-PCR), ma attualmente non esistono test standardizzati per amplificare in modo specifico FIPV.
Prima che si scoprisse che FCoV poteva avere una distribuzione sistemica, un test RT-PCR positivo su un campione non gastroenterico era sinonimo di FIP. Oggi non è più così, perché è ormai accettato che la RT-PCR quantitativa sia necessaria e che la FIP sia associata a un’elevata carica virale. Tuttavia, si deve tener presente che non esiste un test standardizzato universale e che ogni laboratorio ha il proprio test, con caratteristiche specifiche.
Il rilevamento del virus nel sangue, anche mediante RT-PCR, non è utile. Infatti, la carica virale nel sangue è molto bassa, anche in caso di FIP, e il rischio di falsi negativi è alto.
Per i gatti con segni clinici aspecifici associati alla FIP secca, come apatia, febbre intermittente, appetito capriccioso, perdita di peso, la diagnosi rimane molto complicata. È necessario scegliere test con un’ottima specificità per limitare i rischi di falsi positivi. La diagnosi si basa anche sull’esclusione di altre cause. La sierologia e la RT-PCR eseguite su un campione di sangue non forniscono informazioni affidabili.
È necessario determinare la carica virale in un tessuto colpito, mediante RT-PCR quantitativa. Pertanto, in caso di coinvolgimento oculare o di segni neurologici, è necessario eseguire rispettivamente una centesi di umor acqueo o liquido cerebrospinale. A seconda dei segni clinici, può essere necessario eseguire una biopsia del fegato, del rene o del linfonodo mesenterico. Solo una carica virale molto elevata conferma la diagnosi di FIP. Ancora una volta, ogni laboratorio ha sviluppato la propria RT-PCR quantitativa, con propri cutoff.
Prevenire la FIP
Nella lotta alla FIP, il rischio di contaminazione da FeCV deve essere limitato, dal momento che FIPV sembra essere poco contagioso, o si deve limitare il rischio di infezione da FIPV nei gatti, nonostante la presenza di FeCV. La prima strategia corrisponde alla profilassi sanitaria, mentre la seconda, che prevede la vaccinazione, è la profilassi medica.
Data l’altissima prevalenza di FCoV e la sua modalità di trasmissione, è quasi impossibile eradicarlo. D’altra parte, anche se i geni di suscettibilità rimangono sconosciuti, l’ereditarietà dei tratti di suscettibilità genetica è stata dimostrata. Occorre quindi escludere dalla riproduzione i genitori a cui discendenza ha sviluppato la FIP.
Alcuni autori raccomandano anche di identificare i gatti escretori e di isolarli in modo permanente. Questa strategia richiede l’esecuzione di più test RT-PCR distanziati nel tempo con un numero di test e a un intervallo non definiti. Sebbene promettente sulla carta, questa strategia è complicata e costosa da attuare.
Limitare l’esposizione dei gatti agli individui escretori potrebbe, a lungo termine, basarsi anche su un nuovo approccio medico valutato di recente, con l’uso di un preparato medicinale non referenziato in Europa. Sebbene la sua formula sia segreta, viene descritto come un analogo nucleotidico dell’adenosina che bloccherebbe la replicazione e l’escrezione di FCoV.
In questo studio iniziale, 29 gatti escretori di FCoV, provenienti da cinque famiglie diverse, sono stati trattati per 4-7 giorni con il prodotto. In tutti i gatti è stata osservato un arresto dell’escrezione fecale di FCoV. Anche se questi risultati sembrano promettenti, si tratta di uno studio osservazionale di breve durata, senza gruppo di controllo, condotto su una coorte molto piccola e utilizzando un farmaco privo di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC).
La seconda strategia è la profilassi medica, con la vaccinazione degli animali a rischio. Esiste un vaccino commercializzato in alcuni Paesi, inclusi gli Stati Uniti. Si tratta di un vaccino vivo attenuato, con un ceppo termosensibile di FIPV genotipo II. Questo vaccino viene somministrato per via intranasale ai gattini dall’età di 16 settimane.
I risultati di efficacia e sicurezza mostrano che il vaccino può essere utile solo se gli animali sono indenni da FCoV al momento dell’infezione. Esistono alcune prove che suggeriscono che il vaccino possa essere responsabile dell’ADE nei gattini positivi a FCoV. Tutti questi dati hanno portato gli esperti dell’American Animal Hospital Association (AAHA) e dell’American Association of Feline Practitioners (AAFP) a sconsigliare l’uso di questo vaccino contro la FIP.
Le cure disponibili
La FIP è una malattia quasi sempre mortale. Il trattamento di base è una terapia con corticosteroidi a dosi immunosoppressive, somministrando la dose efficace più bassa. Questo trattamento permette di migliorare il benessere dei gatti e di aumentare l’aspettativa di vita, ma non permette di ottenere una guarigione dall’infezione virale.
Nuove terapie sono attualmente in fase di sperimentazione, in particolare con molecole antivirali che mirano alla replicazione del virus. L’obiettivo è trovare inibitori specifici degli enzimi virali essenziali per la replicazione, ma che non abbiano effetto sul metabolismo cellulare. Tra i target più promettenti vi sono le proteasi virali, enzimi essenziali per lo sviluppo del virione e la sua infettività.
Due studi preliminari dimostrano che il composto GC376, un inibitore delle proteasi virali, ha un effetto benefico sul decorso clinico della malattia. Nelle infezioni sperimentali, 6 gattini trattati su 8 sono guariti e sono rimasti sani per almeno 8 mesi dopo l’interruzione del trattamento. In un secondo studio su gatti di proprietà, 7 gattini su 20 con FIP spontanea hanno mostrato una remissione clinica e sono sopravvissuti (uno di loro è stato seguito fino a 14 mesi dopo la fine del trattamento). Ma sono necessari ulteriori studi per confermare questi risultati incoraggianti.
L’altra opzione antivirale consiste nell’interferire con la replicazione del virus utilizzando analoghi nucleotidici. Due molecole, inizialmente sviluppate per l’uomo, sono state testate nei gatti: GS-5734 e il suo metabolita plasmatico attivo GS 441524. Si tratta di un analogo nucleotidico dell’adenosina, che altera la funzione dell’RNA polimerasi, diminuendo così la produzione di RNA virale e, quindi, il numero di particelle virali. La struttura e la modalità di azione di GS-441524 sono probabilmente molto simili a quelle del preparato descritto nel paragrafo precedente.
Il primo studio è stato condotto su 12 gatti infettati sperimentalmente. Dopo 24-48 ore la comparsa dei segni clinici compatibili con la FIP, i gatti sono stati trattati giornalmente per 2 settimane con GS-441524. I 10 gatti malati hanno mostrato una remissione clinica dopo 2 settimane di trattamento, mentre i restanti 2, che sono andati incontro a recidiva, sono stati sottoposti a un secondo trattamento identico. Tutti i gatti trattati sono rimasti asintomatici durante il periodo di controllo di 8 mesi.
GS-441524 è stato quindi testato su una trentina di gatti affetti da FIP. Gli animali hanno ricevuto GS-441524 quotidianamente per via sottocutanea per un minimo di 12 settimane. I risultati hanno mostrato una remissione clinica rapida e duratura (monitoraggio di 9-18 mesi) nella maggior parte dei gatti trattati (25 su 31). GS-441524 è stato anche testato su un ridotto numero di gatti con FIP neurologica od oculare, per i quali i risultati clinici sono incoraggianti.
Per quanto riguarda gli effetti avversi, lo studio non ha rilevato alcun evento grave. Si deve comunque considerare che il prodotto è irritante e che le iniezioni sono dolorose.
Uno studio recente mostra l’efficacia del GS-441524 somministrato per via orale nel trattamento dei gatti con FIP. In questo studio prospettico, 18 gatti (FIP+) sono stati trattati per 84 giorni e tutti sono andati incontro a un miglioramento clinico molto rapido. Tuttavia, in questo studio, non è stata effettuata la valutazione delle possibili recidive al termine del trattamento.
Il GS-441524 ha quindi mostrato un buon rapporto rischio/beneficio contro la peritonite infettiva felina in piccole coorti. Sfortunatamente, con l’arrivo della Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2) e l’uso del GS-5734 nell’uomo, gli studi sull’impiego nel gatto sono diventati più difficili. Nessuna delle due molecole ha attualmente l’autorizzazione all’immissione in commercio in medicina veterinaria in Europa, e per questo è attualmente impossibile prescriverli. Tuttavia, l’entusiasmo legato ai risultati promettenti dei primi studi, il clamore mediatico associato e l’assenza di alternative terapeutiche hanno favorito lo sviluppo di un mercato nero molto ampio, principalmente dalla Cina.
Recentemente, GS-5734 e GS-441524 sono ufficialmente disponibili in alcuni Paesi, tra cui Australia e Regno Unito.
Altre strategie antivirali hanno dimostrato una certa efficacia in vitro (RNA interference) o in vivo (U18666A, inibitore della sintesi e del trasporto del colesterolo) a seguito di infezioni sperimentali, ma è ora necessario effettuare studi di innocuità ed efficacia sul campo prima di considerare il loro sviluppo.
Prospettive incoraggianti
La FIP è tuttora una malattia infettiva molto complicata da gestire. L’iter diagnostico impone la combinazione di un approccio clinico con esami complementari sequenziali. Mentre in medicina umana sono stati prodotti vaccini efficaci a priori contro SARS-Cov-2 in meno di un anno, per il gatto non esiste ancora un vaccino che abbia dimostrato interesse in campo.
Indipendentemente dall’entità dei mezzi messi in atto per lo sviluppo dei vaccini in medicina umana, l’assenza di vaccini per il gatto può essere spiegata dalla particolare biologia di FIPV e, in particolare, dal suo tropismo per i monociti e dal fenomeno ADE associato.
Viceversa, mentre fino a oggi le sperimentazioni cliniche con molecole antivirali hanno dato risultati deludenti nell’uomo, i primi studi nel gatto sono incoraggianti. Sono ora necessari studi complementari che consentano di ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio per poter utilizzare queste molecole nella specie felina.
Bibliografia
- Addie DD, Kennedy LJ, Ryvar R et coll. Feline leucocyte antigen class II polymorphism and susceptibility to feline infectious peritonitis. J. Feline Med. Surg. 2004;6:59-62.
- Addie DD, Curran S, Bellini F et coll. Oral Mutian® X stopped faecal feline coronavirus shedding by naturally infected cats. Res. Vet. Sci. 2020;130:222-229.
- Anses. Covid-19 : pas de rôle des animaux domestiques dans la transmission du virus à l’homme. www.anses.fr. 2020.
- Barker EN, Lait P, Ressel L et coll. Evaluation of interferon-gamma polymorphisms as a risk factor in feline infectious peritonitis development in non-pedigree cats: a largecohort study. Pathogens. 2020;9:535.
- Bessière P, Fusade-Boyer M, Walch M et coll. Household cases suggest that cats belonging to owners with COVID-19 have a limited role in virus transmission. Viruses. 2021;13:673.
- Bubenikova J, Vrabelova J, Stejskalova K et coll. Candidate gene markers associated with fecal shedding of the feline enteric coronavirus (FECV). Pathogens. 2020;9:958.
- Dickinson PJ, Bannasch M, Thomasy SM et coll. Antiviral treatment using the adenosine nucleoside analogue GS-441524 in cats with clinically diagnosed neurological feline infectious peritonitis. J. Vet. Intern. Med. 2020;34:1587-1593.
- Felten S, Hartmann K. Diagnosis of feline infectious peritonitis: a review of the current literature. Viruses. 2019;11:1068.
- Halfmann PJ, Hatta M, Chiba S et coll. Transmission of SARS-CoV-2 in domestic cats. N. Engl. J. Med. 2020;383:592-594.
- Hartmann K, Binder C, Hirschberger J et coll. Comparison of different tests to diagnose feline infectious peritonitis. J. Vet. Intern. Med. 2003;17:781-790.
- Hartmann K. Feline infectious peritonitis. Vet. Clin. North Am. Small Anim. Pract. 2005;35(1):39-79, vi.
- Hosie MJ, Hofmann-Lehmann R, Hartmann K et coll. Anthropogenic infection of cats during the 2020 COVID-19 pandemic. Viruses. 2021;13:185.
- Hsieh LE, Chueh LL. Identification and genotyping of feline infectious peritonitis-associated single nucleotide polymorphisms in the feline interferon-γ gene. Vet. Res. 2014;45:57.
- Jaimes JA, Millet JK, Stout AE et coll. A tale of two viruses: the distinct spike glycoproteins of feline coronaviruses. Viruses. 2020;12:83. 15.
- Kedward-Dixon H, Barker EN, Tasker S et coll. Evaluation of polymorphisms in inflammatory mediator and cellular adhesion genes as risk factors for feline infectious peritonitis. J. Feline Med. Surg. 2020;22(6):564-570.
- Kennedy MA. Feline infectious peritonitis: update on pathogenesis, diagnostics, and treatment. Vet. Clin. North Am. Small Anim. Pract. 2020;50:1001-1011.
- Kim Y, Liu H, Galasiti Kankanamalage AC et coll. Reversal of the progression of fatal coronavirus infection in cats by a broad-spectrum coronavirus protease inhibitor. PLoS Pathog. 2016;12:e1005531.
- Klein-Richers U, Hartmann K, Hofmann-Lehmann R et coll. Prevalence of feline coronavirus shedding in German catteries and associated risk factors. Viruses. 2020;12:1000.
- Krentz D, Zenger K, Alberer M et coll. Curing cats with feline infectious peritonitis with an oral multi-component drug containing GS-441524. Viruses. 2021;13:2228.
- Lauzi S, Stranieri A, Giordano A et coll. Origin and transmission of Feline coronavirus type I in domestic cats from Northern Italy: a phylogeographic approach. Vet. Microbiol. 2020;244:108667.
- Malbon AJ, Meli ML, Barker EN et coll. Inflammatory mediators in the mesenteric lymph nodes, site of a possible intermediate phase in the immune response to feline coronavirus and the pathogenesis of feline infectious peritonitis? J. Comp. Path. 2019;166:69-86.
- Murphy BG, Perron M, Murakami E et coll. The nucleoside analog GS-441524 strongly inhibits feline infectious peritonitis (FIP) virus in tissue culture and experimental cat infection studies. Vet. Microbiol. 2018;219:226-233.
- Pedersen NC. An update on feline infectious peritonitis: virology and immunopathogenesis. Vet. J. 2014;201:123-132.
- Pedersen NC. A review of feline infectious peritonitis virus infection: 1963-2008. J. Feline Med. Surg. 2009;11:225-258.
- Pedersen N, Kim Y, Liu H et coll. Efficacy of a 3C-like protease inhibitor in treating various forms of acquired feline infectious peritonitis. J. Feline Med. Surg. 2018;20(4):378-392.
- Pedersen NC, Perron M, Bannasch M et coll. Efficacy and safety of the nucleoside analog GS-441524 for treatment of cats with naturally occurring feline infectious peritonitis. J. Feline Med. Surg. 2019;21(4):271-281.
- Porter E, Tasker S, Day MJ et coll. Amino acid changes in the spike protein of feline coronavirus correlate with systemic spread of virus from the intestine and not with feline infectious peritonitis. Vet. Res. 2014;45:49.
- Sailleau C, Dumarest M, Vanhomwegen J et coll. First detection and genome sequencing of SARS-CoV-2 in an infected cat in France. Transbound. Emerg. Dis. 2020;67:2324-2328.
- Stone AE, Brummet GO, Carozza EM et coll. 2020 AAHA/AAFP feline vaccination guidelines. J. Feline Med. Surg. 2020;22:813-830.
- Stranieri A, Scavone D, Paltrinieri S et coll. Concordance between histology, immunohistochemistry, and RT-PCR in the diagnosis of feline infectious peritonitis. Pathogens. 2020;9:852.
- Takano T, Kawakami C, Yamada S et coll. Antibody-dependent enhancement occurs upon re-infection with the identical serotype virus in feline infectious peritonitis virus infection. J. Vet. Med. Sci. 2008;70:1315-1321.