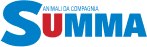Nella prima delle tre parti dedicate alla trattazione della dermatite atopica, Séverine Boullier, prof.ssa di immunologia e vaccinologia all’École Nationale Vétérinaire di Tolosa (Francia) ha illustrato i meccanismi patogenetici alla base della dermatite atopica del cane e del gatto.
La dermatite atopica in medicina veterinaria
La dermatite atopica rappresenta una patologia importante in medicina veterinaria, per la sua frequenza, le difficoltà legate alla sua gestione terapeutica e la grave alterazione della qualità della vita e del benessere degli animali colpiti.
Per definizione, la dermatite atopica è inizialmente una reazione di ipersensibilità di tipo I che coinvolge allergeni, immunoglobuline E (IgE), mastociti e granulociti eosinofili. È ormai accettato che la fisiopatologia della dermatite atopica è estremamente complessa e non si limita a una “semplice” ipersensibilità di tipo I. Si tratta di una malattia multifattoriale, a decorso cronico, che coinvolge numerose cellule, mediatori immunitari talvolta in eccesso o antagonisti e cascate di segnalazioni complesse. Per adattare al meglio il protocollo terapeutico a ciascun caso, è importante comprendere le basi delle alterazioni immunologiche osservate a carico della cute.
Fisiopatologia della dermatite atopica
Il meccanismo immunologico dell’ipersensibilità di tipo I
La caratteristica principale dell’ipersensibilità di tipo I è la sintesi di anticorpi specifici, le IgE. La risposta delle IgE è in linea di principio limitata a un numero ristretto di antigeni, ma alcuni animali mostrano una scarsa regolazione della loro risposta immunitaria, con un forte orientamento verso un profilo di tipo Th2. Questi soggetti producono IgE, mentre una risposta adattata richiederebbe immunoglobuline G (IgG) o A (IgA). Questa è la definizione di atopia.
Nell’ipersensibilità di tipo 1 si distinguono tre fasi: di sensibilizzazione, di latenza e scatenante, durante la quale si manifestano i segni clinici.
La fase di sensibilizzazione corrisponde al primo contatto dell’organismo con l’antigene responsabile della risposta immunitaria alterata. Questo antigene, detto allergene, è una molecola a basso peso molecolare (10-70 kDa), solubile, in grado di attraversare facilmente le mucose. Gli allergeni sono diversi e molto numerosi e, a seconda della loro natura si classificano in pneumoallergeni (inalati), trofallergeni (ingeriti) e inoculati.

La fase di latenza corrisponde all’instaurarsi della risposta immunitaria contro l’allergene e dura circa 3 settimane. La risposta immunitaria contro gli allergeni è caratterizzata da una risposta di tipo Th2, con un’aumentata sintesi di interleuchina 4 (IL-4) da parte dei linfociti T CD4, che induce la produzione di IgE allergene-specifiche da parte dei linfociti B. Le IgE circolanti sono difficili da rilevare e hanno un’emivita molto breve (meno di 2 giorni). Si trovano principalmente nelle mucose e nei tessuti connettivi, dove si legano ai mastociti grazie a un particolare recettore, il FcRe. In seguito a tale legame l’emivita delle IgE aumenta da 3 a 6 settimane. I mastociti che hanno fissato le IgE sono detti sensibilizzati.
La fase scatenante è caratterizzata dalla comparsa di segni clinici. Corrisponde al contatto dell’organismo già sensibilizzato con l’antigene, contatto che può avvenire diversi mesi o addirittura diversi anni dopo la fase di sensibilizzazione. L’allergene penetra facilmente nelle mucose o nei tessuti connettivi e viene riconosciuto dalle IgE specifiche fissate ai mastociti. Il riconoscimento dell’allergene da parte delle IgE attiva immediatamente i mastociti, che rilasciano il contenuto dei loro granuli nei tessuti e/o nel flusso sanguigno, a seconda della loro localizzazione. I granuli dei mastociti contengono mediatori infiammatori molto potenti, tra cui istamina, serotonina, leucotrieni e prostaglandine.
Nei cani, come negli esseri umani, l’istamina predomina sulla serotonina. Il rilascio dei granuli avviene da pochi secondi a pochi minuti dopo il contatto dell’allergene con il mastocita sensibilizzato. È il rilascio di questi mediatori il responsabile dei primi segni clinici.
A seconda della localizzazione dell’allergene e del grado di sensibilizzazione dell’animale, i sintomi sono più o meno marcati. Il perdurare del contatto con l’antigene determina l’inizio nella fase cronica dell’atopia. Nel caso della dermatite atopica, è spesso durante questa fase cronica che i proprietari conducono il loro animale dal medico veterinario. Nella fase cronica vengono coinvolti molti leucociti infiammatori, compresi i granulociti eosinofili. Queste cellule vengono reclutate in seguito alla sintesi permanente di IL-4 e IL-5 da parte dei linfociti T CD4 allergene-specifici, che esprimono, come i mastociti, FcRe e sono quindi sensibilizzati. La loro degranulazione nei tessuti provoca il rilascio di proteasi molto potenti che partecipano alla distruzione dei tessuti e al mantenimento dell’infiammazione.
Il reclutamento e l’attivazione dei leucociti infiammatori non consente la normale guarigione del tessuto interessato.
La risposta immunitaria cutanea
La cute è un organo complesso, che svolge un ruolo chiave come barriera contro i microrganismi. I meccanismi di protezione sono fisici (impermeabilità), chimici (sostanze antimicrobiche) e microbiologici (il microbiota cutaneo sano compete con la flora patogena). Qualsiasi alterazione di una di queste tre qualità della cute facilita l’insediamento o la penetrazione degli antigeni, compresi i microrganismi patogeni e gli allergeni. Il mantenimento dell’omeostasi cutanea è quindi essenziale.
La cute è anche un organo molto ricco di effettori immunitari, il cui ruolo è quello di eliminare il più rapidamente possibile qualsiasi antigene che sia riuscito a superare le barriere aspecifiche. La cute è quindi molto ricca di cellule che intervengono nell’immunità innata.
Le prime cellule sentinella della cute sono i cheratinociti che, durante l’aggressione, secernono citochine infiammatorie (IL-34, eotassina, thymus and activation-regulated chemokine ecc.), consentendo il reclutamento di nuovi leucociti. La cute è anche molto ricca di cellule presentanti l’antigene, che partecipano alla creazione di una risposta immunitaria specifica attivando i linfociti T.
Questo è anche un sito di pattuglia per i linfociti della memoria, che possono attivarsi immediatamente se incontrano il loro antigene specifico. Esiste una circolazione specifica di linfociti coinvolti nella risposta della mucosa. I linfociti attivati a livello delle mucose circolano preferenzialmente nella mucosa di partenza, ma anche nella cute. Questa caratteristica spiega perché le allergie alimentari possono provocare segni clinici cutanei.
Le novità in tema di meccanismo immunologico della dermatite atopica
Per la dermatite atopica si devono tener presenti due punti molto importanti: si tratta sempre di un meccanismo immunopatologico caratterizzato da deregolazione/errore del sistema immunitario e gli animali vengono sottoposti a visita quasi sempre durante la fase cronica, durante la quale molti fattori contribuiscono all’infiammazione della cute. Spesso, quindi, l’antigene iniziale responsabile dell’innesco della risposta atopica non è identificabile e le IgE svolgono solo un ruolo secondario.
Tuttavia, anche se le IgE non sono più direttamente coinvolte, studi recenti confermano che la dermatite atopica è un processo infiammatorio pro-Th2 e che le citochine legate a questa risposta immunitaria svolgono un ruolo fondamentale. Circoli viziosi di attivazione mantengono e aggravano la dermatite atopica.
Recenti scoperte migliorano la conoscenza dei meccanismi immunopatologici della dermatite atopica e contribuiscono all’espansione dell’arsenale terapeutico veterinario.

Nella dermatite atopica, i cheratinociti sono sensibilizzati in un ambiente pro-Th2. In questo contesto, in risposta alla stimolazione, sintetizzano citochine che sono esse stesse pro-Th2. I cheratinociti partecipano quindi al mantenimento della dermatite atopica.
Molte citochine sono coinvolte in queste fasi croniche. È stato recentemente dimostrato che una di esse, l’interleuchina 31 (IL-31), partecipa all’innesco del prurito attivando i neuroni sensoriali, che sono molto numerosi a livello cutaneo. L’IL-31 stimolerebbe anche la crescita di questi neuroni sensoriali, aumentando così la sensibilità cutanea. In aggiunta, l’IL-31 attiva anche i leucociti attivati, in particolare quelli coinvolti nelle risposte Th2. I linfociti T della memoria sono la principale fonte di IL-31. Nella dermatite atopica, quindi, esiste un circolo vizioso di automantenimento dell’infiammazione Th2.
È stato inoltre riportato che l’IL-31 altera la biologia dei cheratinociti, diminuendo la sintesi delle proteine coinvolte nella formazione delle giunzioni serrate e riducendo quindi l’integrità della cute. Una delle conseguenze è la presenza di infezioni cutanee batteriche secondarie nelle aree infiammatorie. Uno studio rivela inoltre che la cute dei cani atopici è molto più ricca di stafilococchi rispetto a quella dei cani sani.
Modalità d’azione delle molecole utilizzate per il trattamento della dermatite atopica
Data la sua complessità e la sua natura multifattoriale, la gestione della dermatite atopica è multimodale. I progressi nella conoscenza dei meccanismi immunopatologici della dermatite atopica, parallelamente allo sviluppo dell’immunoterapia in medicina veterinaria, hanno permesso di ampliare il range terapeutico disponibile per gestire questa patologia. Tuttavia, data la complessità della fisiopatologia della dermatite atopica, le diverse molecole devono essere utilizzate in modo ragionato per ogni paziente. Va inoltre tenuto presente che nessuno di questi trattamenti immunomodulatori e antiprurito tratta la causa della malattia.
I glucocorticoidi
I glucocorticoidi sono stati per lungo tempo l’unico trattamento immunosoppressivo disponibile e sono ancora importanti per la gestione della dermatite atopica. Si tratta di molecole molto potenti, le cui attività immunosoppressive sono molto ampi.
Dopo essersi legati al recettore citosolico, i glucocorticoidi modificano la trascrizione di circa l’1% dei geni delle cellule immunitarie. Oltre al loro effetto antinfiammatorio marcato e rapido, diminuiscono la fagocitosi dei fagociti e la loro capacità di presentare l’antigene ai linfociti T. Hanno anche un effetto diretto sui linfociti T, bloccandone l’attivazione.
Oltre alla loro attività antinfiammatoria immediata, i glucocorticoidi contribuiscono quindi a rompere il circolo vizioso di automantenimento della risposta atopica, riducendo la risposta specifica. Queste molecole agiscono anche su altre cellule dell’organismo e il loro uso prolungato è associato a numerosi effetti collaterali, talvolta gravi.

Nella figura a fianco. Dopo aver attraversato la membrana cellulare, i corticosteroidi si legano al loro recettore e formano omodimeri. Questi ultimi inducono l’attivazione di fattori di trascrizione che modificano i livelli di trascrizione (effetti di attivazione o soppressione) di molti geni. Sulle cellule immunitarie, i glucocorticoidi hanno un effetto immunosoppressore.
La ciclosporina
La ciclosporina è il secondo immunomodulatore utilizzato da molti anni nei cani e nei gatti. Essa inibisce una proteina citoplasmatica, la calcineurina, coinvolta nella trascrizione di molti geni che codificano per le citochine. Come i glucocorticoidi, ha un ampio spettro d’azione. Oltre alla sua attività sui linfociti T, la ciclosporina ha dimostrato di avere un’azione specifica sulle cellule presentanti l’antigene presenti nella cute, le cellule di Langerhans. Parteciperebbe quindi alla neutralizzazione dell’automantenimento della risposta cutanea specifica limitando l’attivazione e la differenziazione di nuovi effettori T.
Per contro, la ciclosporina non ha un effetto antinfiammatorio immediato. I suoi effetti clinici sono quindi visibili solo dopo alcune settimane di trattamento, quando la risposta immunitaria T-dipendente è neutralizzata. Anche se la molecola è abbastanza ben tollerata nel cane e nel gatto, il blocco aspecifico dell’attivazione dei linfociti T può essere associato a un’aumentata suscettibilità agli agenti infettivi e al rischio della comparsa di processi neoplastici.

Nella figura a fianco la modalità d’azione della ciclosporina sui linfociti T. A = Durante la risposta immunitaria, vari segnali di attivazione inducono l’attivazione della calcineurina, che partecipa alla trascrizione dei geni che codificano per le interleuchine 2 e 4 (IL-2 e IL-4). B = La ciclosporina inibisce l’attivazione della calcineurina e blocca la sintesi di IL-2 e IL-4 da parte dei linfociti T.
Gli inibitori delle Janus chinasi
Sono ora disponibili nuove molecole per la gestione della dermatite atopica. La prima è l’oclacitinib, un inibitore delle vie di segnalazione delle Janus chinasi. Le Janus chinasi (JAK) sono enzimi coinvolti nella trasduzione del segnale indotto dal legame delle citochine infiammatorie ai loro recettori cellulari. Una volta attivati, le JAK iniziano la trascrizione dei geni bersaglio. Esistono quattro JAK, legati a recettori delle citochine diversi. Formano una rete complessa per regolare la trascrizione dei segnali di attivazione forniti dalle citochine.
L’oclacitinib inibisce prevalentemente JAK1, coinvolta nella cascata di segnalazione delle citochine Th2. In particolare, è stato dimostrato che il blocco di JAK1 diminuisce le principali vie di segnalazione delle citochine chiave dell’atopia, tra cui le interleuchine IL-4, IL-13 e IL-31. L’oclacitinib partecipa anche alla riduzione generale della risposta T-dipendente, bloccando la sintesi di IL-2.
Come per tutti gli immunomodulatori, l’uso a lungo termine dell’oclacitinib può essere associato a rischi di sviluppo di processi neoplastici.

Gli anticorpi monoclonali anti-interleuchina 31
Il trattamento più recente disponibile è molto più mirato. Si tratta di un anticorpo monoclonale specifico per l’IL-31 canina, il lokivetmab. Esiste una significativa specificità di specie per gli anticorpi monoclonali. Questo anticorpo è quindi destinato esclusivamente ai cani e non deve essere utilizzato nei gatti.
L’IL-31 è uno dei mediatori prodotti durante la dermatite atopica e coinvolto nel fenomeno del prurito. Neutralizzando l’IL-31 prima che si leghi al suo recettore cellulare, il lokivetmab contribuisce alla riduzione del prurito. È bene comunque ricordare che altre molecole effettrici possono essere coinvolte nel prurito nei diversi stadi della dermatite atopica. L’efficacia clinica può quindi variare da animale ad animale.

Bibliografia
- Abreu D, Kim BS. Innate immune regulation of dermatitis. Immunol. Allergy Clin. North Am. 2021;41(3):347-359.
- Ahn J, Choi Y, Simpson EL. Therapeutic new era for atopic dermatitis. Part 2: small molecules. Ann. Dermatol. 2021;33(2):101-107.
- Barnes PJ. Pathophysiology of allergic inflammation. Immunol. Rev. 2011; 242(1):31-50.
- Boullier S. Immunologie: l’hypersensibilité de type I. Nouveau Prat. Vét. 2002;2(9).
- Cain DW, Cidlowski JA. Immune regulation by glucocorticoids. Nat. Rev. Immunol. 2017;17(4):233-247.
- De Franco AL, Robertson M, Locksley RM. Dans : Immunité, la réponse immunitaire dans les maladies infectieuses et inflammatoires. De Boeck, Bruxelles. 2009:365p.
- De Mora FA, Puigdemont A, Torres R. The role of mast cells in atopy: what can we learn from canine models? A thorough review of the biology of mast cells in canine and human systems. Br. J. Dermatol. 2006;155(6):1109-1123.
- Gedon NKY, Mueller RS. Atopic dermatitis in cats and dogs: a difficult disease for animals and owners. Clin. Transl. Allergy. 2018;8:41.
- Jahnz-Rozyk K, Targowski T, Paluchowska E et coll. Serum thymus and activationregulated chemokine, macrophage- derived chemokine and eotaxin as markers of severity of atopic dermatitis. Allergy. 2005;60(5):685-688.
- Kabashima K, Irie H. Interleukin- 31 as a clinical target for pruritus treatment. Front. Med. (Lausanne). 2021;8:638325.
- Leung D, Jain N, Leo HL. New concepts in the pathogenesis of atopic dermatitis. Curr. Opin. Immunol. 2003;15(6):634-638.
- Marsella R. Calcineurin inhibitors: a novel approach to canine atopic dermatitis. J. Am. Anim. Hosp. Assoc. 2005;41(2):92-97.
- Marsella R. Advances in our understanding of canine atopic dermatitis. Vet. Dermatol. 2021;32(6):547-e151.
- Nemmer JM, Kuchner M, Datsi A et coll. Interleukin-31 signaling bridges the gap between immune cells, the nervous system and epithelial tissues. Front. Med. (Lausanne). 2021;8:639097.
- Reber LL, Hernandez JD, Galli SJ. The pathophysiology of anaphylaxis. J. Allergy Clin. Immunol. 2017;140(2):335-348.
- Rodrigues Hoffmann A. The cutaneous ecosystem: the roles of the skin microbiome in health and its association with inflammatory skin conditions in humans and animals. Vet. Dermatol. 2017;28(1):60-e15.