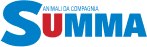Nella terza delle tre parti dedicate alla trattazione della dermatite atopica, è stato preso in esame uno studio retrospettivo francese della durata di 5 anni sugli effetti indesiderati dei principali indicati per il trattamento della dermatite atopica: lokivetmab, oclacitinib e ciclosporina.
Dermatite atopica e gestione terapeutica
La dermatite allergica, che comprende l’allergia ai morsi delle pulci, le allergie alimentari e l’atopia, è una malattia cronica caratterizzata da prurito, che può compromettere notevolmente la qualità di vita dell’animale.

I trattamenti possono stabilizzare l’espressione clinica di questa patologia, che colpisce sia i cani sia i gatti. Attualmente, in questo contesto vengono prescritti principalmente lokivetmab, oclacitinib, ciclosporina e glucocorticoidi. Tuttavia, come per tutti i medicinali, il loro utilizzo può essere associato alla comparsa di effetti collaterali di varia gravità. È quindi essenziale tenere sempre in considerazione il rapporto rischi/benefici di questi principi attivi per l’animale trattato.
Materiali e metodi
L’analisi si è concentrata su tutti i casi gravi1 e non gravi verificatisi in Francia in cani e gatti, in un periodo di cinque anni (dall’1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020) e registrati presso l’Ufficio banca dati dell’Agence nationale de sécurité sanitaire – Agence nationale du médicament vétérinaire (Anses-ANMV). Sono state incluse solo le segnalazioni di farmacovigilanza che soddisfacevano i seguenti criteri.
- Effetto avverso a seguito dell’uso di un medicinale con autorizzazione all’immissione
in commercio (AIC) per il trattamento della dermatite allergica nei cani e/o gatti - Se il medicinale presenta nell’AIC più indicazioni, dichiarazioni relative a un evento verificatosi nell’ambito dell’indicazione “dermatite allergica”
- Nesso causale tra il medicinale e l’effetto avverso non escluso (attribuzione A, B o O1/O secondo la classificazione ABON2)
In base a questi criteri sono stati selezionati i medicinali (di riferimento e generici) contenenti lokivetmab, oclacitinib, ciclosporina o glucocorticoidi (somministrazione sistemica o topica) e per i quali è stata individuata almeno una dichiarazione che soddisfaceva i criteri dello studio. Poiché il lokivetmab è stato commercializzato nel 2017, gli effetti avversi registrati si sono verificati in un periodo più breve rispetto a quello dello studio.
Per ciascun caso considerato sono stati analizzati i dati relativi agli animali colpiti (razza, sesso, età), i trattamenti attuati (molecole, dosaggi) e gli effetti avversi riportati (cronologico, aspetti clinici, evoluzione). Poiché la dermatite allergica è un’entità complessa che coinvolge molti fattori, attualmente sul mercato vengono offerte molteplici terapie. Lo studio non ha affrontato l’uso di allergeni preparati per un solo animale (APSA), antistaminici, copolimeri di acidi grassi e trattamenti igienici. Sono stati esclusi anche gli antiparassitari, alcuni dei quali hanno indicazione anche nella gestione della dermatite allergica.
La stima del numero di animali trattati durante il periodo di studio con ciascun principio attivo è stata fornita dai rispettivi titolari dell’AIC, sulla base dei dati di vendita per le diverse presentazioni di ciascun prodotto e dei dosaggi e delle durate del trattamento convalidati nell’AIC.
L’incidenza stimata degli effetti avversi (rapporto tra il numero di reazioni avverse dichiarate e il numero di animali trattati nel periodo considerato) negli animali trattati per dermatite allergica in Francia è stata calcolata solo per il lokivetmab e l’oclacitinib. Le altre due classi di farmaci (corticosteroidi e ciclosporina), infatti, non sono indicate solo per il trattamento della dermatite allergica. È quindi impossibile determinare quale percentuale di questi farmaci venga utilizzata sul campo per il trattamento di queste condizioni.
Infine, le principali caratteristiche generali delle popolazioni canine e feline francesi sono state determinate grazie ai dati trasmessi dall’istituto di sondaggi Kantar per l’anno 2020, che hanno permesso di stabilire le cifre di riferimento. È stato così possibile effettuare test statistici (C2).
Risultati
Segnalazioni incluse nello studio
Tra le segnalazioni ricevute dall’ANSESANMV, sono stati inclusi nello studio 403 casi nei cani e 109 nei gatti.

Circa il 27% dei casi segnalati nei cani erano gravi, contro il 41% nei gatti. Il rapporto di causalità è risultato non classificabile o inconcludente (attribuzioni O1 e O) nel 52% dei casi nei cani e nel 62% di quelli nei gatti.

Inoltre, una percentuale significativa di segnalazioni includeva diverse molecole (31% dei casi canini e 40% dei casi felini). Anche gli antiparassitari sono comparsi regolarmente come trattamento concomitante (34 casi nei cani, 19 casi nei gatti).
Caratteristiche delle popolazioni canine e feline studiate
Tra le 403 segnalazioni registrate nei cani, la razza più citata è risultata il Bulldog francese (11,7%), seguita da West Highland white terrier (7,4%), Jack russell terrier (4,5%), Yorkshire terrier (4,2%), Labrador retriever (3,7%), Bulldog inglese (2,7%), Pastore tedesco ( 2,7%), Boxer (2,5%), Border collie (1,7%), Shih tzu (1,7%), American Staffordshire terrier (1,5%), Bichon frisé (1,5%) e Bull terrier (1,5%).
È stata osservata una significativa sovrarappresentazione delle razze Bulldog francese (p-value < 0,001) e Boxer (p-value < 0,001). Anche se i criteri per eseguire un test C2 non sono stati soddisfatti, è sembrata emergere una tendenza simile anche per le razze West Highland white terrier (citato in 30 segnalazioni), Bulldog inglese e Bull terrier. Nei gatti, poiché il 91% degli individui erano Europei o incroci, questo criterio non è stato analizzato.
Per quanto riguarda l’età, l’analisi statistica ha rivelato una significativa sovrarappresentazione di cani di età compresa tra 4 e 7 anni (p-value < 0,002) e di età superiore a 11 anni (p-value < 0,01) rispetto alla popolazione di riferimento. Tra i felini, gli individui di età compresa tra 8 e 11 anni sono stati i più rappresentati (p-value <0,05).
Riguardo il genere, nei cani non è stata dimostrata alcuna tendenza degna di nota. Per contro, nei gatti è stata osservata una significativa sovrarappresentazione delle femmine (p-value < 0,05).
Profilo e frequenza degli eventi avversi
Sono stati valutati il profilo degli effetti avversi per ciascuna specialità studiata, la loro frequenza nei cani e nei gatti, nonché il tempo intercorso tra la prima somministrazione del farmaco e la comparsa dell’effetto avverso.


Questi dati non sono presentati in questa sezione per i dermocorticosteroidi, l’oclacitinib usato off-label nei gatti (ridotto numero di casi) e glucocorticoidi orali e iniettabili (ridotto numero di casi, politerapie frequenti e probabile errore nella segnalazione), ma sono menzionati nella discussione. Si deve tener presente che un rapporto di farmacovigilanza può citare congiuntamente diversi effetti avversi.
Lokivetmab
Sono state elencate e analizzate complessivamente 91 segnalazioni riguardanti il cane, di cui il 24% giudicate gravi. Nel 42% dei casi il ruolo del farmaco è considerato possibile o probabile. L’uso concomitante di altri farmaci è stato osservato nel 22% delle segnalazioni.
Quasi il 18% dei casi segnalati riguardava reazioni di ipersensibilità. Questi casi erano caratterizzati principalmente da sintomi cutanei (orticaria, edema facciale, prurito), osservati nelle 48 ore successive all’iniezione, oppure da disturbi gastroenterici (vomito, diarrea), insorti da pochi minuti a poche ore dopo.
Oltre a questi casi di ipersensibilità, il 37% delle segnalazioni menzionava disturbi generali. Si trattava tuttavia di segni aspecifici (letargia, anoressia), spesso associati ad altri sintomi. Tra gli altri effetti avversi segnalati, i disturbi gastroenterici (vomito e diarrea, salvo in contesti di ipersensibilità chiaramente identificata) sono citati nel 24% dei casi, i disturbi cutanei (dermatiti, orticaria, alopecia, prurito) nel 18%, i disturbi neurologici (tremori, atassia e convulsioni) nel 14% e i disturbi comportamentali (cambiamento del comportamento, aggressività) nel 10%. Tre segnalazioni (3% dei casi) hanno riportato un esito fatale, ma il nesso causale con il farmaco non è stato confermato.
Il tempo di insorgenza degli effetti avversi dopo l’ultima iniezione di lokivetmab è risultato inferiore a 5 giorni nella maggior parte dei casi (56%). È in questo lasso di tempo che si è verificato il 43% dei casi gravi. Gli effetti avversi sono comunque comparsi anche più tardi: più di 1 mese (31%) e fino a più di 6 mesi dopo l’inizio del trattamento (16%). Nella stragrande maggioranza (75%) di questi casi “tardivi” (segnalati più di 1 mese dopo l’inizio del trattamento), il nesso causale con le iniezioni di lokivetmab è rimasto inconcludente.
Questi casi apparivano polimorfici (ipersensibilità, disturbi epatici, linfoma, massa nel sito di iniezione, anemia emolitica immunomediata, cistite, disturbi gastroenterici, piometra, diabete ecc.), senza alcuna manifestazione principale che potesse suggerire la comparsa di effetti avversi specifici in seguito all’uso a medio o lungo termine.
L’incidenza degli effetti avversi successivi alla somministrazione di lokivetmab in Francia tra il 2017 e il 2020 è stata infine stimata pari allo 0,08% (1 effetto avverso segnalato in 1.325 cani trattati).
Oclacitinib
Tra le segnalazioni incluse nello studio, 185 riguardavano cani e 7 gatti (uso off-label). I casi felini sono risultati particolarmente polimorfici e il legame tra la somministrazione del farmaco e gli effetti avversi citati è rimasto, nel complesso, inconcludente. Delle 185 segnalazioni riportate per i cani, il 46% degli effetti avversi sono considerati gravi. In quasi la metà dei casi il ruolo dell’oclacitinib è considerato possibile o probabile. L’uso concomitante di altri farmaci è stato osservato nel 31% delle segnalazioni.
Nel 37% dei casi sono stati descritti sintomi generali, tra cui letargia (18%) e anoressia (13%). Particolarmente segnalati sono risultati anche i disturbi gastroenterici, con vomito menzionato nel 18% dei casi e diarrea nel 10%. Sintomi cutanei come infezioni, dermatiti o prurito sono stati riportati nel 19% delle segnalazioni (incluso un caso di demodicosi). Nel 20% dei casi è stato descritto un disturbo neurologico (tremori, atassia, convulsioni). In 12 di questi casi (32%) è stato somministrato in parallelo un antiparassitario esterno o interno.
Inoltre, sono stati segnalati anche 30 casi che presentavano disturbi comportamentali (ovvero il 16%) con aggressività (11%), iperattività (11%) e ansia. Nella maggior parte dei casi, questi cambiamenti comportamentali si sono verificati durante i primi 15 giorni di trattamento. Nel 57% di questi casi il ruolo del farmaco è ritenuto possibile o probabile.
Il 17% delle segnalazioni ha riportato masse o tumori dopo la somministrazione di oclacitinib. In 12 casi (7% delle segnalazioni) sono comparse masse cutanee di natura istologica non conclusiva. Tra le segnalazioni che hanno indicato una diagnosi di tumore erano presenti 5 casi di linfoma, 3 di istiocitoma, 3 di papilloma e 9 di tumori a carico di vari apparati. Inoltre, 16 casi (9%) hanno avuto esito fatale. Per 4 di questi il ruolo di oclacitinib è stato considerato possibile e per 3 di essi è stato associato allo sviluppo di un processo tumorale.
Negli altri casi non è stato possibile trarre una conclusione chiara a causa dell’uso concomitante di altri farmaci, del sospetto di una malattia di base e/o della mancanza di indagini.
Nella maggior parte dei casi (54%) l’effetto avverso si è manifestato entro 15 giorni dall’inizio del trattamento e comprendeva principalmente segni lievi (letargia, disturbi dell’appetito, segni gastroenterici, disturbi comportamentali regolarmente segnalati).
Nel 15% delle segnalazioni l’effetto avverso è stato osservato 1-6 mesi dopo la prima somministrazione e, nel 23% dei casi, più di 6 mesi dopo. Tra i casi segnalati dopo un mese di trattamento, il 30% riguardava la comparsa di masse e tumori e, nel 10% dei casi, l’animale soffriva di cistite o di un’infezione delle vie urinarie. Masse e tumori sono stati segnalati nel 25% dei casi a 1-6 mesi dall’inizio del trattamento e nel 46,4% dei casi più di 6 mesi dopo.
L’incidenza degli effetti avversi successivi alla somministrazione di oclacitinib in Francia tra il 2016 e il 2020 è stata quindi stimata pari allo 0,016% (1 effetto avverso segnalato
in 6.076 cani trattati).
Ciclosporina
Tra le segnalazioni incluse nello studio, 78 casi riguardavano l’uso di ciclosporina nei cani e 74 casi nei gatti. Dato il ridotto numero di casi segnalati, non è stato possibile effettuare un’analisi individuale specifica per ciascun medicinale veterinario.
Analisi degli effetti avversi nel cane
Gli effetti avversi riportati sono stati considerati gravi nel 23% dei casi. Nel 60% dei casi il ruolo della ciclosporina è stato considerato possibile o probabile. L’uso concomitante di altri farmaci è stato osservato nel 28% delle segnalazioni.
I sintomi gastroenterici sono stati quelli descritti più frequentemente (44%), principalmente il vomito (26% dei casi), seguiti dai segni generali, menzionati nel 40% delle dichiarazioni (letargia, polidipsia, perdita di peso) e cutanei (prurito, dermatite, alopecia) nel 22% delle segnalazioni. Segni neurologici (atassia e tremori) sono stati riportati nel 14% dei casi. Infine, sono stati identificati 10 casi di iperplasia gengivale e 9 casi di diabete mellito (di cui 7 nei West Highland white terrier). Per i 2 casi (ovvero il 3%) con esito fatale è stato ritenuto possibile il nesso con la somministrazione del medicinale (diabete mellito, tumore).
Nel 37% dei casi l’effetto avverso si è manifestato durante i primi 5 giorni di trattamento. Per il 92% di essi si trattava di casi non gravi, con vomito nel 36% delle segnalazioni. Inoltre, quasi la metà dei casi relativi alla somministrazione di ciclosporina nei cani sono stati segnalati più di 1 mese dopo l’inizio del trattamento, compreso un 24% di processi tumorali (iperplasia gengivale, papillomi) e un 20% di diabete mellito.
Analisi degli effetti avversi nel gatto
Gli effetti avversi segnalati sono stati considerati gravi nel 34% dei casi. Nel 51% dei casi il ruolo della ciclosporina è stato considerato possibile o probabile. L’uso concomitante di altri farmaci è stato osservato nel 31% delle segnalazioni.
Come nei cani, sono stati segnalati principalmente sintomi gastroenterici (53%) e generali (37%). Sono stati riportati molti casi di ipersalivazione (nel 20%) e una maggiore incidenza della diarrea (19%) e del vomito (30%). L’anoressia è stata descritta nel 18% delle dichiarazioni e la letargia nel 15%. Sono emersi anche alcuni casi di interessamento delle vie urinarie (poliuria, cistite, ematuria) (11%).
Nel 52% dei casi l’effetto avverso è stato segnalato durante i primi 5 giorni di trattamento. Si trattava prevalentemente di casi non gravi (75%) con disturbi gastroenterici (vomito, ipersalivazione e diarrea). Per i 6 casi con esito fatale non è stato possibile stabilire con certezza il nesso causale (mancanza di ulteriori esami).
Discussione
Negli ultimi anni sono state messe a disposizione dei medici veterinari nuove opzioni terapeutiche per controllare il prurito e l’infiammazione che caratterizzano la dermatite allergica. Il trattamento di questi disturbi si basa su una strategia multimodale, che deve essere adattata a ciascun animale. Lo studio retrospettivo descritto fornisce una sintesi degli effetti avversi osservati in Francia e segnalati all’ANSES-ANMV tra il 2016 e il 2020 dopo la somministrazione delle principali molecole raccomandate.
L’analisi dei profili degli effetti avversi ottenuti ha evidenziato alcune tendenze. Sintomi gastroenterici e generali (che possono essi stessi essere secondari a disturbi gastroenterici) sono stati quelli più frequentemente riportati per il lokivetmab, l’oclacitinib e la ciclosporina. Le manifestazioni cutanee sono state regolarmente descritte, ma rimangono difficili da interpretare nel contesto del trattamento della dermatite allergica. È stata riportata anche una percentuale rilevante di sintomi neurologici.
Per quanto riguarda i tempi di insorgenza, la maggior parte degli effetti avversi sono stati descritti durante i primi 15 giorni di trattamento (lokivetmab, oclacitinib) o i primi 5 giorni (ciclosporina nel gatto).
Gli effetti indesiderati segnalati sono stati inoltre per lo più giudicati non gravi (il 76% dei casi ha coinvolto il lokivetmab, il 54% l’oclacitinib, il 77% la ciclosporina nel cane e il 66% nel gatto). Questi dati sono generalmente coerenti con quanto riportato in letteratura, nonché nei riassunti delle caratteristiche del prodotto (RCP). Solo i segni neurologici rilevati nello studio con l’oclacitinib rimangono sorprendenti. I risultati ottenuti hanno permesso inoltre di evidenziare caratteristiche più specifiche per ciascuna famiglia.
L’analisi del profilo dei casi dichiarati per il lokivetmab ha rivelato quindi una buona tolleranza apparente, con effetti indesiderati che rimangono rari. Sarà tuttavia necessario prestare attenzione alle reazioni di ipersensibilità che sono risultate relativamente frequenti. Anche uno studio di 42 giorni condotto negli Stati Uniti su una popolazione di 162 cani atopici selezionati da diversi clienti, ha valutato la sicurezza dell’uso del lokivetmab. In questo studio, confrontando i cani che hanno ricevuto il trattamento e quelli del gruppo di controllo, non è stata dimostrata alcuna differenza significativa nell’espressione degli effetti avversi, consentendo di trarre la conclusione che il lokivemab è molto sicuro. Tuttavia, la durata di questo studio è stata relativamente breve.
Per quanto riguarda il presente studio, la durata è stata necessariamente di 3 anni e, quindi, con una valutazione meno corposa di questa molecola rispetto agli altri farmaci studiati.
In definitiva, gli effetti avversi del lokivetmab non possono essere considerati del tutto noti, soprattutto a lungo termine; da qui l’importanza del feedback della farmacovigilanza.
Anche gli effetti indesiderati conseguenti all’uso dell’oclacitinib sono risultati rari. Dall’analisi delle segnalazioni ricevute sono emerse alcune particolarità: la possibile comparsa di disturbi comportamentali e lo sviluppo di masse e tumori in alcuni cani. Nelle segnalazioni pervenute sono state menzionate anche alcune condizioni legate a un calo delle difese immunitarie (8 casi di cistite e infezione delle vie urinarie, 5 casi di infezioni cutanee, 1 caso di demodicosi).
In uno studio sul campo condotto su 247 cani, i segni clinici più segnalati sono stati infezioni del tratto urinario e cistiti (11,3%), vomito (10,1%), otiti (9,3%), piodermiti (9,3%) e diarree (6,1%). Un processo neoplastico è stato riportato in 16 cani (dopo una media di 238 giorni) e 47 presentavano masse dermiche giudicate benigne. Sono state inoltre descritte variazioni moderate e transitorie di alcuni parametri ematici, con diminuzione del numero dei leucociti e delle piastrine e aumento della colesterolemia e delle proteine totali.
Tutti gli studi attualmente disponibili concludono che questa molecola, in genere, è sicura. A causa delle sue proprietà immunomodulanti, la comparsa di nuove masse e lo sviluppo di tumori richiedono tuttavia un attento monitoraggio.
Va notato che l’oclacitinib è stato utilizzato off-label in 7 casi che hanno riportato effetti avversi nei gatti. I quadri clinici associati a questi casi sono stati particolarmente polimorfici e, nel complesso, non è stato dimostrato alcun chiaro legame tra gli effetti avversi riportati e la somministrazione di oclacitinib (indagini insufficienti per escludere altre ipotesi).
A oggi sono disponibili in letteratura pochi dati riguardanti l’utilizzo di questa molecola nei felini. L’effetto della somministrazione di oclacitinib nei gatti è stato analizzato in due studi condotti nell’arco di 1 mese. In uno di essi è dimostrato solo un moderato aumento dei parametri renali.
Per quanto riguarda l’efficacia dell’oclacitinib nel controllo della dermatite allergica, alcuni studi hanno riportano risultati incoraggianti. Tuttavia, è stato ora dimostrato che i gatti metabolizzano questa molecola più rapidamente rispetto ai cani, determinando un aumento della frequenza di somministrazione e/o della dose prescritta.
In conclusione, anche se l’oclacitinib sembra poter costituire un’opzione terapeutica nel gatto, l’esiguo numero di studi attualmente disponibili, condotti anche su numeri ridotti di animali e per brevi periodi, invita ad attendere per avere maggiori informazioni che consentono una valutazione più precisa del rapporto rischi/benefici per questa specie.
Per quanto riguarda la ciclosporina, gli effetti avversi associati al suo utilizzo sono attualmente ben documentati (molecola presente sul mercato da più tempo). Nello studio presentato sono stati descritti 9 casi di perdita di peso nel cane e 7 casi nel gatto, un parametro per cui è necessario un attento monitoraggio.
Sono emerse alcune differenze nei segni osservati nei cani e nei gatti. L’ipersalivazione, più frequente nei gatti, potrebbe essere attribuita al cattivo gusto del farmaco. Nel cane, sono stati rilevati 10 casi di iperplasia gengivale e 9 casi di diabete mellito che hanno interessato, in 7 casi, la razza West Highland white terrier. Questi effetti avversi sono coerenti con i dati riportati in letteratura.
Nel cane e nel gatto, contrariamente a quanto osservato nell’uomo, la ciclosporina non sembra essere particolarmente nefrotossica. Una metanalisi ha stimato che circa il 55% dei cani trattati con questa molecola ha avuto almeno un effetto avverso. Tuttavia, la maggior parte di questi eventi non sono risultati gravi e l’interruzione del trattamento è stata necessaria solo nel 4% dei casi. Pertanto, l’incidenza stimata degli effetti avversi dopo l’uso della ciclosporina rimane complessivamente bassa, con effetti indesiderati poco frequenti.
In ogni caso, i profili degli effetti avversi di questo studio dovrebbero essere interpretati tenendo presente che le distorsioni inerenti alla farmacovigilanza sono inevitabili.
La prima è la sotto-segnalazione, in quanto viene segnalato solo il 10% degli effetti avversi. Inoltre, quelli considerati gravi sono generalmente più dichiarati rispetto a quelli giudicati poco rilevanti.
Inoltre, i medici veterinari tendono a segnalare più effetti avversi per i prodotti commercializzati più di recente che per i prodotti più datati, considerati già noti.
Infine, non sempre è stato possibile stabilire un forte nesso causale (attribuzione A o B), il che significa che gli elementi descritti non hanno consentito di determinare l’esatto ruolo del farmaco. Ciò potrebbe essere legato, in particolare, all’uso concomitante di più molecole.
Pertanto, in una parte significativa delle dichiarazioni dello studio descritto (125 casi canini, ovvero il 31%, e 44 casi felini, ovvero il 40%), viene riportata la politerapia.
Come prevedibile, gli antiparassitari esterni, raccomandati nel contesto della gestione della dermatite allergica, fanno spesso parte dell’elenco dei farmaci somministrati in parallelo e potenziali responsabili degli effetti avversi descritti. In particolare, nel 32% delle segnalazioni che descrivono segni neurologici e coinvolgono l’oclacitinib, è stato somministrato anche un antiparassitario esterno, mettendo in dubbio il reale ruolo di questa molecola nell’insorgenza dei segni clinici. Inoltre, in caso di somministrazione simultanea di diverse sostanze, sono sempre possibili interazioni farmacologiche.
Infine, il confronto delle incidenze stimate degli effetti avversi, il cui calcolo può basarsi solo su approssimazioni nel quadro di malattie complesse come la dermatite allergica, deve essere effettuato con cautela. I dati ottenuti con i glucocorticoidi non son sembrati rilevanti, a causa delle distorsioni menzionate in precedenza, particolarmente marcate per questa famiglia.
Per quanto riguarda i glucocorticoidi orali e iniettabili, sono state registrate 32 segnalazioni nei cani (34% degli effetti avversi considerati gravi) e 21 nei gatti (67% degli effetti considerati gravi), con la maggior parte dei casi che riguardano vari farmaci (63% nei cani contro 86% nei gatti) e portando a circa il 75% i casi assegnati a O1/O.
Inoltre, dato l’esiguo numero di casi, è stata condotta un’analisi complessiva, indipendentemente dalla via di somministrazione, che ha evidenziato soprattutto sintomi generali (letargia, anoressia per entrambe le specie e ipotermia nel gatto), gastroenterici e neurologici. Un’ampia percentuale di segni respiratori è stata riportata anche nei felini (28,6% dei casi). L’esito fatale si è verificato nel 16% dei cani e nel 33% dei gatti.
Questi risultati, per alcuni autori, concordano poco con i dati della letteratura. Il profilo degli effetti avversi legati all’uso dei farmaci di questa famiglia, che da decenni rappresentano il trattamento d’elezione delle dermatiti allergiche e di molteplici patologie, può essere considerato oggi generalmente ben noto (segni gastroenterici, poliuria-polidipsia, polifagia, aumento ponderale, diabete, complicanze infettive, ritardi di cicatrizzazione, disturbi comportamentali ecc.).
La prescrizione di corticosteroidi è oggi maggiormente riservata alla gestione degli attacchi acuti, eventualmente a complemento di altre terapie. Talvolta, viene preferito l’uso di corticosteroidi topici (idrocortisone aceponato), caratterizzati da una ridotta percentuale di assorbimento cutaneo, poiché consentono un’azione localizzata in caso prurito acuto e, in alcuni casi, offrono un sufficiente sollievo all’animale a lungo termine, evitando gli effetti avversi dei glucocorticoidi somministrati per via sistemica.
Nello studio sono state riportate solo 24 segnalazioni riguardanti corticosteroidi topici (uso off-label): 17 casi canini e 7 casi felini, inclusi 21 casi assegnati a O1/O. In 17 di queste segnalazioni, sono stati riportati anche disturbi cutanei di natura variabile. Lo studio descritto ha permesso anche di far emergere qualche tendenza riguardanti gli animali che sviluppano effetti avversi.
Si è notata una maggiore rappresentazione di alcune razze (Bulldog francese, Boxer). Sebbene sia ormai accertato che la dermatite allergica possa verificarsi in tutte le razze, alcuni disturbi dermatologici, come la dermatite atopica, sono più comunemente descritti nei Retriever, nei Pastori tedeschi, nei Bulldog, nei Boxer e nei West Highland white terrier, in diversi studi condotti in tutto il mondo. Tuttavia, questi studi soffrono di distorsioni e i risultati dipendono dalla maggiore presenza di determinate razze in alcune regioni geografiche.
Il Boxer e il Bulldog francese, due razze che spiccano nello studio descritto, sono tra quelle che sembrano predisposte all’atopia in Europa. La sovrarappresentazione di queste razze sembra quindi essere più legata a queste predisposizioni, piuttosto che a una maggiore sensibilità ai farmaci prescritti per il loro trattamento.
Sono stati maggiormente rappresentati anche gli animali di età compresa tra 4 e 7 anni, che può corrispondere all’età media di somministrazione dei primi trattamenti. La sovrarappresentazione dei cani di età superiore a 11 anni e dei gatti di 8-11 anni può essere spiegata da uno stato di salute più fragile legato alla vecchiaia (possibili malattie intercorrenti).
Nel cane, non è stato dimostrato alcun effetto del sesso dell’animale, che quindi non costituisce un fattore predisponente, né per la dermatite allergica come riportato in letteratura, né per la manifestazione di effetti avversi a seguito della somministrazione dei trattamenti oggetto di studio. Per quanto riguarda la sovrarappresentazione delle femmine nei gatti, è possibile che sia la conseguenza di una minore percentuale di gatti maschi non castrati sottoposti a trattamento e non di una maggiore sensibilità ai farmaci prescritti o di una particolare predisposizione alla dermatite allergica delle femmine.
Conclusioni
La scelta del trattamento della dermatite allergica deve essere adattata alla patologia da trattare (gravità, intensità e ripercussioni dei segni clinici), ma anche al profilo dell’animale (età, patologie intercorrenti, trattamenti concomitanti). In questa valutazione del rapporto rischio/beneficio per l’animale, una buona conoscenza degli effetti avversi dei medicinali considerati è importante quanto quella della loro efficacia. Anche se per la maggior parte delle sostanze attualmente raccomandate gli effetti avversi sono generalmente rari e per lo più non gravi, resta il fatto che, in genere, si tratta di trattamenti lunghi e che è essenziale un monitoraggio regolare.
Resta fondamentale il ruolo dei medici veterinari nel progresso della conoscenza di questi farmaci e si deve incoraggiare la loro partecipazione attiva e regolare al sistema di farmacovigilanza, tramite la segnalazione degli effetti avversi osservati.
- Una reazione avversa grave è un evento che provoca segni clinici permanenti o prolungati, dà luogo a un’alterazione o a una malformazione congenita o causa un handicap o un’incapacità significativa che può mettere in pericolo la vita dell’animale
o provocarne la morte. ↩︎ - Il confronto di tutti i dati disponibili con i dati bibliografici e con i precedenti casi registrati porta a un’assegnazione, ossia a una classificazione del caso in una delle quattro categorie (A, B, O, N) previste dalle linee guida dell’European medicines agency. Esprime il legame tra il farmaco somministrato e i segni clinici osservati: A (probabile), B (possibile), O1 (inconcludente), O (non classificabile) e N (improbabile). Per la valutazione dell’imputabilità vengono considerati diversi fattori: l’associazione nel tempo, compresa un’eventuale scomparsa o recidiva dei sintomi alla sospensione del trattamento o nel corso di somministrazioni ripetute o la corrispondenza anatomica (in particolare con il sito di iniezione o di applicazione del farmaco); il profilo farmaco-tossicologico, le concentrazioni ematiche e l’esperienza maturata con il medicinale; la presenza di elementi clinici o patologici caratteristici; l’esclusione di altre possibili cause; la completezza e l’attendibilità dei dati forniti dalla segnalazione del caso; la misurazione quantitativa del grado di contributo di un farmaco allo sviluppo di un evento avverso (rapporto dose-effetto). ↩︎
Bibliografia
- Botoni LS, Torres SMF, Koch SN et coll. Comparison of demographic data, disease severity and response to treatment, between dogs with atopic dermatitis and atopic-like dermatitis: a retrospective study. Vet. Dermatol. 2019;30(1):10-e4.
- Cosgrove SB, Cleaver DM, King VL et coll. Long-term compassionate use of oclacitinib in dogs with atopic and allergic skin disease: safety, efficacy and quality of life. Vet. Dermatol. 2015;26(3):171-179.
- Elkholly DA, Brodbelt DC, Church DB et coll. Side effects to systemic glucocorticoid therapy in dogs under primary veterinary care in the UK. Front. Vet. Sci. 2020;7:515.
- Fernandes KSBR, Ferreira MB, da Silva AM et coll. Eficácia do oclacitinib no manejo da síndrome da atopia felina. Acta Sci. Vet. 2019;47:374-379.
- Ferrer L, Carrasco I, Cristòfol C et coll. A pharmacokinetic study of oclacitinib maleate in six cats. Vet. Dermatol. 2020;31(2):134-137.
- Fresnay E, Laurentie S, Orand JP. La sous-déclaration en pharmacovigilance vétérinaire : étude de cas d’événements indésirables dus aux médicaments vétérinaires. Bull. GTV. 2015;80:95-102.
- Gedon NKY, Mueller RS. Atopic dermatitis in cats and dogs: a difficult disease for animals and owners. Clin. Transl. Allergy. 2018;8:41.
- Gortel K. An embarrassment of riches: an update on the symptomatic treatment of canine atopic dermatitis. Can. Vet. J. 2018;59(9):1013-1016.
- Herrmann I, Einhorn L, Panakova L. Gender aspects in allergies of pets – A secondary publication and update. World Allergy Organ. J. 2017;10(1):42.
- Jaeger K, Linek M, Power HT et coll. Breed and site predispositions of dogs with atopic dermatitis: a comparison of five locations in three continents. Vet. Dermatol. 2010;21(1):118-122.
- Kovalik M, Thoday KL, van den Broek AH. The use of ciclosporin A in veterinary dermatology. Vet. J. 2012;193(2):317- 325.
- Little PR, King VL, Davis KR et coll. A blinded, randomized clinical trial comparing the efficacy and safety of oclacitinib and ciclosporin for the control of atopic dermatitis in client-owned dogs. Vet. Dermatol. 2015;26(1):23-30.
- Lopes NL, Campos DR, Machado MA et coll. A blinded, randomized, placebocontrolled trial of the safety of oclacitinib in cats. BMC Vet. Res. 2019;15(1):137.
- Michels GM, Walsh KF, Kryda KA et coll. A blinded, randomized, placebocontrolled trial of the safety of lokivetmab (ZTS-00103289), a caninized anti-canine IL-31 monoclonal antibody in client-owned dogs with atopic dermatitis. Vet. Dermatol. 2016;27(6):505-e136.
- Moyaert H, Van Brussel L, Borowski S et coll. A blinded, randomized clinical trial evaluating the efficacy and safety of lokivetmab compared to ciclosporin in clientowned dogs with atopic dermatitis. Vet. Dermatol. 2017;28(6):593-e145.
- Mueller RS, Nuttall T, Prost C et coll. Treatment of the feline atopic syndrome – A systematic review. Vet. Dermatol. 2021;32(1):43-e8.
- Noli C, Matricoti I, Schievano C. A double-blinded, randomized, methylprednisolone-controlled study on the efficacy of oclacitinib in the management of pruritus in cats with nonflea nonfood-induced hypersensitivity dermatitis. Vet. Dermatol. 2019;30(2):110-e30.
- Nuttall TJ, McEwan NA, Bensignor E et coll. Comparable efficacy of a topical 0.0584% hydrocortisone aceponate spray and oral ciclosporin in treating canine atopic dermatitis. Vet. Dermatol. 2012;23(1):4-10.
- Nuttall T, Reece D, Roberts E. Life-long diseases need life-long treatment: long-term safety of ciclosporin in canine atopic dermatitis. Vet. Rec. 2014;174(Suppl 2):3-12.
- Ortalda C, Noli C, Colombo S et coll. Oclacitinib in feline nonflea-, nonfoodinduced hypersensitivity dermatitis: results of a small prospective pilot study of client-owned cats. Vet. Dermatol. 2015;26(4):235-e52.