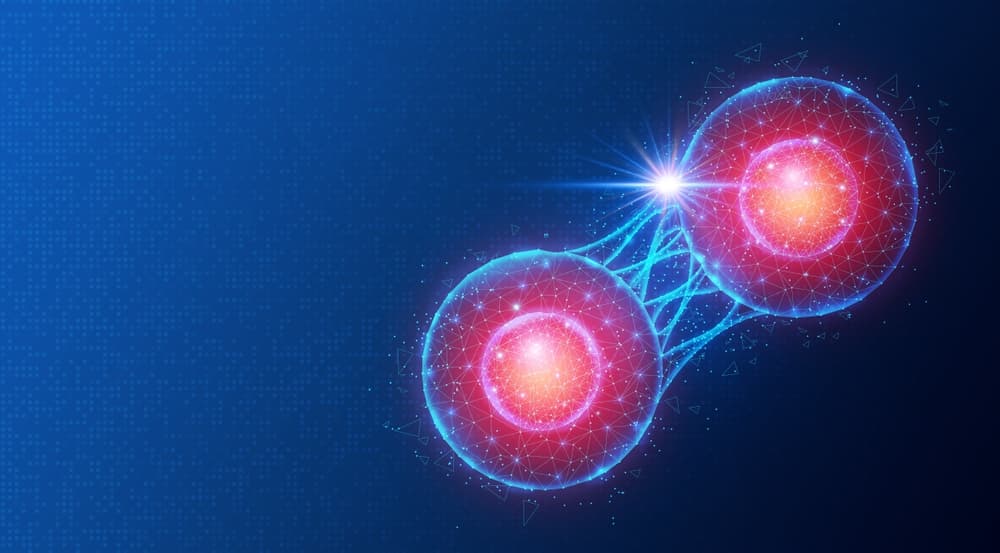Volge alla conclusione, con il penultimo incontro, il ciclo di webinar dedicato alle cellule mesenchimali stromali (MSC) e il loro utilizzo in Veterinaria, organizzato da GISMVet (Gruppo Italiano Staminali Mesenchimali – Sezione Veterinaria) con la collaborazione della piattaforma CogitoErgoVet.
In questa occasione, la prof.ssa Silvia Dotti (IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna) ha introdotto due relazioni che si focalizzano su aspetti fondamentali dell’utilizzo pratico di queste cellule: nella prima, la prof.ssa Luisa Pascucci (Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Perugia) ha illustrato i prodotti terapeutici derivati dalle MSC; nella seconda, la prof.ssa Alessandra Pelagalli (Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate dell’Università di Napoli Federico II) si è soffermata sulle interazioni delle MSC con i più comuni farmaci usati in Veterinaria.
Prodotti terapeutici derivanti dalle cellule mesenchimali stromali
Le MSC rappresentano una frontiera innovativa nel campo della medicina rigenerativa veterinaria. Queste cellule, derivate da varie fonti tissutali come il midollo osseo, il tessuto adiposo e il cordone ombelicale, sono note per le loro proprietà rigenerative che vanno oltre il semplice meccanismo sostitutivo che consiste nel rimpiazzare cellule danneggiate o morte: studi recenti dimostrano infatti che questo meccanismo non è sufficiente a spiegare gli effetti delle MSC, anche in considerazione del loro scarso attecchimento nel tessuto lesionato (1- 5% delle cellule somministrate) e della breve sopravvivenza in vivo.
Nonostante queste limitazioni, le MSC riescono a stimolare efficacemente il tessuto ricevente, suggerendo che il loro meccanismo terapeutico sia più complesso. Una parte significativa della loro efficacia risiede infatti nelle molecole bioattive da esse secrete, che includono citochine, fattori di crescita e microRNA. Questi componenti sono in grado di modulare il microambiente circostante, promuovendo la rigenerazione dei tessuti danneggiati e mitigando il processo infiammatorio.
Le azioni biologiche delle cellule MSC
- Attività immunomodulatoria, regolando l’infiammazione sia acuta che cronica
- Produzione di fattori paracrini e autocrini, cruciali per la rigenerazione tessutale
- Potenziale di differenziazione in diversi tipi cellulari
- Attività migratoria, che consente loro di localizzarsi nei siti di lesione
L’universo del secretoma
Il termine secretoma indica tutto ciò che le MSC riversano nell’ambiente extracellulare e che rappresenta il principale effettore della loro azione biologica. Il secretoma rappresenta il cuore delle loro proprietà terapeutiche, in quanto crea un ambiente pro-rigenerativo in grado di favorire la guarigione.
Le principali funzioni del secretoma sono:
- Azione antinfiammatoria: riduzione dei processi infiammatori locali e sistemici.
- Immunomodulazione: regolazione delle risposte immunitarie per evitare reazioni immunologiche avverse.
- Neoangiogenesi: stimolazione della formazione di nuovi vasi sanguigni essenziali per la rigenerazione tissutale.
- Azione anti-apoptotica: prevenzione della morte cellulare.
- Rimodellamento tissutale: ricostruzione della struttura e della funzionalità del tessuto danneggiato.
Il secretoma delle MSC si suddivide in due componenti principali: la frazione solubile e le vescicole extracellulari (EVs).
La frazione solubile comprende proteine, citochine, fattori di crescita e altre molecole bioattive, come il TGF-β, l’EGF, il VEGF e l’FGF. Questi elementi cooperano per promuovere processi di rigenerazione tissutale.
Vescicole extracellulari: un’alternativa alle terapie tradizionali
Le EVs costituiscono una componente fondamentale del secretoma e sono oggetto di crescente interesse. Queste vescicole, comprendenti esosomi e microvescicole, fungono da vettori naturali per il trasporto di molecole bioattive come RNA, DNA e proteine.
Uno dei principali vantaggi delle EVs è la loro capacità di proteggere il contenuto bioattivo durante il trasporto, garantendo un rilascio mirato ed efficace. Le EVs possono attraversare le barriere biologiche, come la barriera emato-encefalica, rendendole un’opzione terapeutica promettente per malattie neurologiche sia negli animali che negli esseri umani.
Le EVs possono essere purificate a partire dal surnatante di coltura delle MSC mediante tecniche avanzate, come l’ultracentrifugazione, l’ultrafiltrazione, la filtrazione tangenziale, la cromatografia ad esclusione molecolare (SEC), l’immunoprecipitazione. Le EVs possono inoltre essere caricate con farmaci, proteine, RNA o DNA e utilizzate come vettori terapeutici altamente specifici. Questa caratteristica le rende una valida alternativa alle terapie tradizionali, soprattutto nei casi in cui sia necessario un rilascio localizzato e prolungato.

Le strategie di rilascio includono l’ingegnerizzazione genetica delle cellule donatrici per produrre EVs specificamente caricate, oppure il caricamento diretto delle EVs con molecole terapeutiche post-isolamento. Inoltre, la possibilità di modificare la superficie delle EVs per migliorarne la biocompatibilità o aumentare la loro affinità verso determinati tessuti target rappresenta un ulteriore progresso tecnologico.
Rispetto ai sistemi di rilascio sintetici come i liposomi, le EVs offrono alcuni vantaggi significativi:
- specificità naturale: le EVs possiedono molecole di superficie naturali che le rendono intrinsecamente capaci di interagire con tessuti specifici;
- carico bioattivo complesso: a differenza dei liposomi, le EVs contengono una combinazione di proteine, RNA e lipidi che contribuiscono alla loro attività terapeutica;
- tollerabilità biologica: essendo derivate da cellule, le EVs mostrano una tolleranza immunologica superiore rispetto ai liposomi sintetici.
Questo confronto evidenzia come le EVs possano essere una soluzione ottimale per numerose applicazioni, pur necessitando di miglioramenti tecnologici per competere in termini di produzione, standardizzazione e scalabilità.
Applicazioni veterinarie: una nuova frontiera terapeutica
In Medicina Veterinaria, l’uso del secretoma e delle EVs è documentato da alcuni lavori scientifici, per lo più condotti in vitro. I pochi lavori in vivo riguardano l’uso del secretoma tal quale o in forma liofilizzata (liosecretoma) nel trattamento di tendini e articolazioni di cavallo e cane. I lavori citati hanno dimostrato la sicurezza del prodotto impiegato e una promettente efficacia, che va ancora ulteriormente indagata.
Utilizzare secretoma o EVs come prodotti “off-the-shelf”, ovvero pronti per l’uso, fornirebbe un incredibile vantaggio. Questo approccio eliminerebbe la necessità di isolare cellule dal paziente e coltivarle, riducendo i tempi del trattamento. In particolare, i prodotti liofilizzati garantiscono stabilità a lungo termine e facilità di conservazione, ampliando le possibilità di impiego su scala globale.
I limiti attuali e le prospettive future
Nonostante i progressi significativi, esistono ancora alcune criticità nell’applicazione del secretoma e delle EVs. Tra le principali sfide vi sono:
- mancanza di standardizzazione: la variabilità tra i lotti di produzione e la mancanza di protocolli unici rappresentano un ostacolo per l’adozione su larga scala;
- costo elevato: i processi di produzione e purificazione richiedono tecnologie avanzate, che ne aumentano i costi;
- sicurezza e regolamentazione: sebbene il secretoma e le EVs siano considerati sicuri, sono necessari ulteriori studi per definire protocolli di somministrazione ottimali e verificare eventuali effetti avversi a lungo termine.
Il secretoma e le EVs stanno trasformando il panorama della medicina rigenerativa, offrendo soluzioni innovative e versatili.
Guardando al futuro, si delineano diverse prospettive interessanti per la medicina rigenerativa oltre all’uso di cellule. Tra le possibilità più promettenti vi sono:
- prodotti a base di secretoma;
- prodotti a base di EVs;
- EVs ingegnerizzate con tecnologie avanzate per modificare geneticamente le EVs, migliorandone la specificità terapeutica;
- componenti selettivi di secretoma o EVs, come proteine o microRNA;
- prodotti combinati dati dall’integrazione di MSC e secretoma o EVs per massimizzare l’efficacia dei trattamenti.
Sebbene siano ancora necessarie ulteriori ricerche per affrontare le sfide tecniche e regolatorie, il loro potenziale terapeutico è innegabile. Grazie alla possibilità di utilizzo come prodotti “off-the-shelf” e alla crescente integrazione di tecnologie avanzate, il futuro di queste terapie sembra promettente, sia in ambito umano che veterinario. Attraverso un impegno continuo nella ricerca e nello sviluppo, il secretoma e le EVs potrebbero presto diventare strumenti di riferimento nella pratica clinica globale.
Le cellule mesenchimali stromali e le loro interazioni con i farmaci di uso comune
Abbiamo visto come le MSC rappresentino un’importante risorsa per la medicina rigenerativa e la terapia immunomodulatoria, grazie alle loro proprietà di differenziazione, immunomodulazione e secrezione di fattori bioattivi. Tuttavia, l’integrazione delle MSC con i farmaci di uso comune nella pratica clinica veterinaria richiede un’attenta analisi delle possibili interazioni e degli effetti sinergici o avversi, anche perché molti degli studi effettuati sono in vitro.

L’utilizzo combinato di MSC e farmaci è comune in vari ambiti della clinica veterinaria:
- durante gli interventi chirurgici: per garantire analgesia e supporto alla guarigione;
- nella gestione del dolore: tramite anestetici locali e farmaci antinfiammatori;
- per la terapia di patologie su base immuno-mediata, come l’artrite reumatoide.
Interazioni con anestetici locali
Gli anestetici locali, fondamentali per molte procedure veterinarie, possono essere distinti, secondo la loro natura chimica, in esteri (cocaina, procaina, tetracaina, ecc.) in amidi (lidocaina, bupivacaina, ropivacaina, ecc.)
Gli studi evidenziano che:
- l’incubazione di MSC adipose (Ad-MSC) con lidocaina, mepivacaina e ropivacaina non ne compromette significativamente la vitalità, sebbene alte dosi di bupivacaina (10 mM) riducano la vitalità del 40%;
- le proprietà di differenziazione adipogenica, condrogenica e osteogenica risultano ridotte fino al 40-60% in presenza di anestetici a concentrazioni elevate.
Effetti su differenziazione e secretoma
Gli anestetici locali influenzano anche la secrezione di fattori bioattivi:
- VEGF: promotore dell’angiogenesi e della guarigione delle ferite;
- IL-6 e IL-8: modulano l’infiammazione e la risposta immunitaria;
- HGF: ridotto fino al 40% con lidocaina e mepivacaina.
I risultati mostrano come gli anestetici locali, utilizzati in concentrazioni clinicamente rilevanti, non compromettano in modo significativo la vitalità o il secretoma delle MSC. Tuttavia, gli studi in vitro potrebbero non rappresentare appieno la complessità delle condizioni in vivo. Questi dati richiedono ulteriori conferme per tradurli efficacemente nella pratica clinica.
Interazioni con antibiotici
Gli antibiotici mostrano effetti variabili sulle MSC; alcuni studi evidenziano che la combinazione con antibiotici non ha effetti negativi, migliorando anzi la riduzione di alcune citochine pro-infiammatorie e promuovendo la rigenerazione tessutale.
Inoltre, le MSC possiedono un potenziale antimicrobico intrinseco, che può essere potenziato dall’uso combinato con antibiotici.
Gli studi più recenti, inclusi modelli preclinici, hanno dimostrato che:
- nel trattamento dell’artrite settica e infezioni da impianti causate da Staphylococcus aureus, la combinazione di MSC (adipose o da cordone ombelicale) con antibiotici migliora i punteggi di osteomielite e riduce l’osteolisi e la carica microbica;
- l’uso combinato non ha evidenziato effetti negativi sulla vitalità delle MSC, dimostrando invece una sinergia nella riduzione delle citochine pro-infiammatorie, come IL-6 e TNF-α.
Un aspetto cruciale riguarda l’impatto degli antibiotici sulle capacità proliferative e differenziative delle MSC:
- penicillina, gentamicina e ceftiofur: alle dosi comunemente utilizzate in clinica, non alterano la vitalità né il comportamento proliferativo delle MSC;
- amikacina: a concentrazioni elevate (>25.000 mg/ml), induce una citotossicità significativa (>80%), compromettendo anche la funzione delle cellule sinoviali e dei condrociti;
- gli effetti avversi sembrano essere dose-dipendenti e richiedono una valutazione accurata delle concentrazioni somministrate.
Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS)
I FANS hanno proprietà antinfiammatorie, analgesiche e antipiretiche, agendo sull’inibizione della sintesi delle prostaglandine: questo meccanismo di azione è rilevante per comprendere il loro impatto sul microambiente cellulare, inclusa la funzione delle MSC.
Effetto dell’ibuprofene
Uno studio recente ha evidenziato che l’ibuprofene, somministrato a concentrazioni terapeutiche (25-50 μg/ml), non compromette la capacità di proliferazione, migrazione e differenziamento delle MSC. Tuttavia, si registra una significativa riduzione della secrezione di PGE2 (-80% rispetto al controllo) e un cambiamento nel profilo del secretoma, con diminuzione di ICAM-1 e HGF. Questi risultati suggeriscono che l’ibuprofene potrebbe influenzare il ruolo immunomodulatore delle MSC.
Effetto dell’indometacina
L’indometacina, altro FANS analizzato, sembra favorire il differenziamento adipocitario rispetto a quello osteogenico delle MSC, agendo tramite il pathway di PPARγ. Inoltre, in un modello sperimentale di artrite indotta, l’associazione MSC + Indometacina ha dimostrato di ridurre lo stress ossidativo e modulare i livelli di citochine pro-infiammatorie (IL-1β) e anti-infiammatorie (IL-4), con un effetto complessivamente terapeutico.
Effetto del celecoxib
Il celecoxib, inibitore selettivo della COX-2, ha mostrato risultati promettenti in vivo. Associato alle MSC, migliora la capacità di riparazione delle ferite, con una riduzione delle cellule immunitarie nel sito di lesione e una modulazione dell’IL-17. Questo suggerisce un potenziale per combinazioni terapeutiche mirate in condizioni infiammatorie croniche.
Effetti degli immunosoppressori sulle MSC
Gli immunosoppressori, utilizzati per gestire patologie autoimmuni o per evitare il rigetto nei trapianti, possono influire sulle capacità funzionali delle MSC. Gli studi analizzati mostrano risultati variegati in funzione del tipo di farmaco e della dose somministrata.
Gli immunosoppressori testati (idrocortisone, desametasone, metotressato, azatioprina e 6-mercaptopurina) mostrano un’inibizione significativa della proliferazione, migrazione e secrezione citochinica delle MSC, in particolare quando sottoposte a trattamenti prolungati (4 giorni). L’azione inibitoria varia tra i farmaci, con idrocortisone e desametasone che presentano un impatto maggiore.
La risposta delle MSC agli immunosoppressori dipende non solo dal farmaco, ma anche da fattori legati al microambiente e al donatore delle cellule. È stato evidenziato come le MSC adipose (Ad-MSC) siano generalmente più resistenti rispetto ad altre fonti cellulari; questo suggerisce che il contesto clinico e il tipo di cellule utilizzate debbano essere attentamente valutati prima di intraprendere trattamenti combinati.
Un aspetto critico riguarda i rischi di trombosi associati all’infusione sistemica di MSC: infatti, possono innescare risposte infiammatorie acute (IBMI), compromettendo la loro efficacia; tuttavia, i dati suggeriscono che un bilancio tra attività pro-coagulante e fibrinolitica potrebbe mitigare tali rischi.
Eparina e MSC: cosa aspettarci?
L’eparina, un anticoagulante ampiamente utilizzato, è stata studiata per le sue interazioni con le MSC. Gli studi più recenti (2019-2022) hanno analizzato i suoi effetti sulla vitalità, proliferazione e differenziamento.
Effetti sul fenotipo e differenziamento. In modelli tridimensionali, l’eparina sembra stimolare l’attività osteogenica delle MSC, migliorando la capacità rigenerativa ossea. Inoltre, in studi in vivo, l’eparina ha mostrato di potenziare l’angiogenesi, aumentando i livelli di VEGF e promuovendo la vascolarizzazione nei siti di lesione. Risultati clinici. La combinazione MSC + eparina si è dimostrata efficace nel ridurre la superficie tissutale danneggiata, suggerendo una sinergia terapeutica che potrebbe essere sfruttata per migliorare la rigenerazione tissutale nei contesti veterinari.
L’elevato potenziale terapeutico delle cellule mesenchimali stromali
Gli studi analizzati suggeriscono che le interazioni tra MSC e farmaci di uso comune presentano un elevato potenziale terapeutico, sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per ottimizzare i trattamenti. In generale:
- gli anestetici locali e i FANS mostrano effetti dose-dipendenti sulla funzione e vitalità delle MSC, richiedendo un’attenzione particolare nel contesto clinico. Gli anestetici locali e gli antibiotici, alle concentrazioni clinicamente rilevanti, non compromettono significativamente la vitalità o la funzionalità delle MSC;
- la sinergia tra MSC e antibiotici apre nuove possibilità nel trattamento delle infezioni resistenti;
- gli immunosoppressori possono limitare l’efficacia delle MSC, sottolineando l’importanza di personalizzare le terapie in base al tipo di farmaco e al paziente;
- l’eparina si è rivelata un ottimo coadiuvante per migliorare i processi rigenerativi, in particolare nell’angiogenesi.

L’uso combinato di MSC con farmaci può offrire vantaggi terapeutici, specialmente in condizioni infiammatorie e infettive complesse. Tuttavia, è essenziale proseguire con ulteriori studi in vivo per confermare i dati ottenuti in laboratorio e sviluppare protocolli standardizzati che ottimizzino l’efficacia terapeutica, minimizzando i rischi di interazioni avverse.
Per maggiori informazioni:
- Guillaume VGJ, et al. Comprehensive Analysis of Local Anesthetics Affecting Adipose Stem Cells In Vitro. Plast Reconstr Surg. 2023;152(5):850e-861e. doi:10.1097/ PRS.0000000000010460.
- Kearney CM, et al. Treatment effects of intra-articular allogenic mesenchymal stem cell secretome in an equine model of joint inflammation. Front Vet Sci. 2022; 9:907616. Published 2022. doi:10.3389/fvets.2022.907616.
- Lange-Consiglio A, et al. Conditioned medium from horse amniotic membrane-derived multipotent progenitor cells: immunomodulatory activity in vitro and first clinical application in tendon and ligament injuries in vivo. Stem Cells Dev. 2013; 22(22):3015-3024. doi:10.1089/ scd.2013.0214.
- Mocchi M, et al. Equine mesenchymal stem/stromal cells freeze-dried secretome (lyosecretome) for the treatment of musculoskeletal diseases: production process validation and batch release test for clinical use. Pharmaceuticals (Basel). 2021;14(6):553. doi:10.3390/ph14060553.
- Parker RA, et al. The in vitro effects of antibiotics on cell viability and gene expression of equine bone marrow-derived mesenchymal stromal cells. Equine Vet J. 2012;44(3):355-360. doi:10.1111/j.2042-3306.2011.00437.x.
- Pezzanite L, et al. Amikacin induces rapid dose-dependent apoptotic cell death in equine chondrocytes and synovial cells in vitro. Equine Vet J. 2020;52(5):715-724. doi:10.1111/ evj.13243.
- Sung PH, et al. Synergic effect of combined xenogeneic mesenchymal stem cells and ceftriaxone on acute septic arthritis. Stem Cells Transl Med. 2024;13(8):724-737. doi:10.1093/ stcltm/szae034.
- Van der Meel R, et al. Extracellular vesicles as drug delivery systems: lessons from the liposome field. J Control Release. 2014;195:72-85. doi:10.1016/j.jconrel.2014.07.049.
- Yoshitani J, et al. Combinational therapy with antibiotics and antibiotic-loaded adipose-derived stem cells reduce abscess formation in implant-related infection in rats. Sci Rep. 2020;10(1):11182. Published 2020 Jul 7. doi:10.1038/ s41598-020-68184-y.