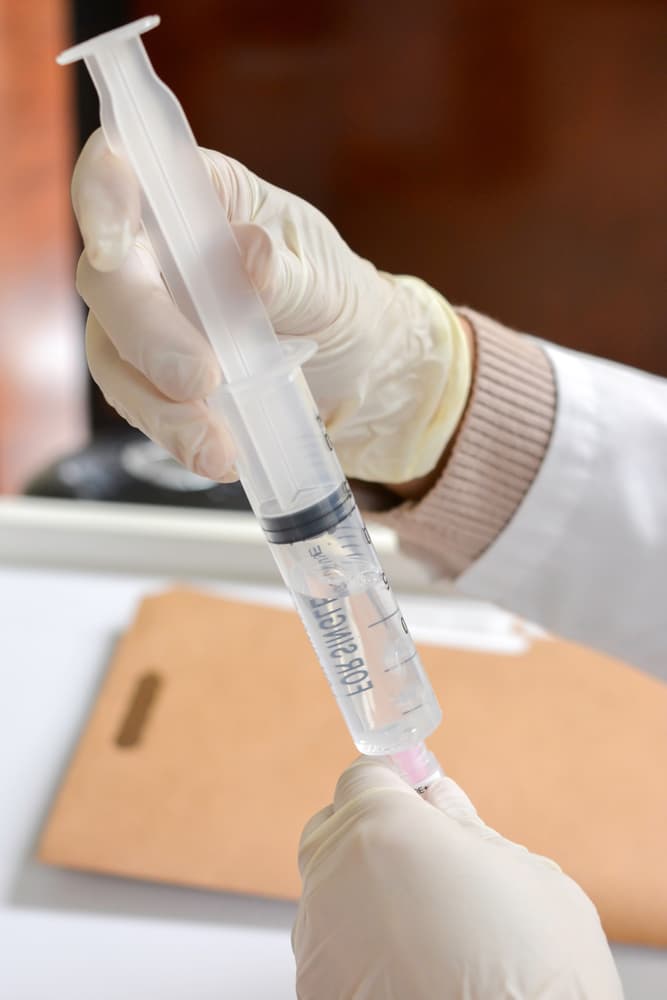Proseguono gli incontri del percorso formativo 2024 del GISMVet (Gruppo Italiano Staminali Mesenchimali Sezione Veterinaria) dal titolo: “Cellule mesenchimali stromali (MSC) e terapie rigenerative in ambito veterinario”. Nel terzo webinar1 due gli argomenti trattati, entrambi di taglio pratico per il professionista veterinario che intenda avvalersi di queste promettenti terapie cellulari.
Le cellule mesenchimali stromali hanno esigenze di gestione complesse
La prof.ssa Anna Lange Consiglio, del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze animali dell’Università di Milano, ha coordinato l’incontro. Il primo argomento, “Gestione del trasporto e conservazione delle MSC”, è stato trattato dal prof. Stefano Grolli, del Dipartimento di Scienze Medico veterinarie dell’Università di Parma, che vanta una decennale esperienza in questo campo. Da tempo, infatti, si occupa di medicina rigenerativa e di messa a punto di protocolli terapeutici nel cane e nel gatto.

Bisogna sempre tenere presente, quando si usano MSC, che le cellule non sono molecole chimiche. Le cellule sono entità viventi, e hanno esigenze molto più complesse, per cui la loro gestione, conservazione e somministrazione può impattare sull’efficacia delle terapie. Il veterinario ha un ruolo sempre attivo; ogni sua manualità deve essere svolta in modo preciso e influisce sulla buona riuscita della terapia stessa. La complessità di queste terapie è dovuta al fatto che le MSC sono farmaci viventi, quindi necessitano, per la loro conservazione, di adeguate condizioni ambientali, (pH, osmolarità, temperatura, nutrienti, ecc).
Inoltre, ottenere un numero adeguato di cellule da un tessuto richiede numerosi passaggi, ognuno influenzabile da scelte e manualità dell’operatore. Partendo dal prelievo del tessuto, per arrivare alla somministrazione del farmaco cellulare, sono necessari numerosi passaggi fondamentali, ognuno dei quali deve essere effettuato con la piena consapevolezza dei requisiti da applicare.
- Il veterinario decide quale tessuto raccogliere, dopo di che lo spedisce al laboratorio, responsabile di isolare e amplificare le cellule, preparandole per l’applicazione. Durante la raccolta del tessuto, il veterinario deve effettuare il prelievo, costituito di solito da tessuto adiposo, applicando le più rigide condizioni di sterilità chirurgica.
- In seguito, il tessuto deve essere conservato e spedito al laboratorio, mantenendo sterilità e vitalità del tessuto stesso. Si usano soluzioni addizionate di antibiotico che consentano corrette condizioni ambientali. Di solito la più usata è la soluzione fisiologica tamponata con sali di fosfato. In alternativa si possono usare l’HBSS, (Hank’s balanced salt solution), oppure un medium di coltura. Usare soluzione salina o ringer per questi scopi, non essendo tamponate, può danneggiare le cellule. Temperature di refrigerazione o ambiente (4-8 °C; 20-24 °C) devono essere utilizzate in questa fase per il trasporto. Nel primo caso la consegna deve essere effettuata entro le 24 ore, nel secondo, entro 6-8 ore. Si tratta, in buona sostanza, di scegliere un contenitore adeguato, antibiotici adeguati e soluzione di trasferimento adeguata. In questa fase non è consigliato il congelamento. In laboratorio, si sceglie la tecnica per isolare e moltiplicare le cellule. Una volta fatto questo, il materiale deve ritornare al veterinario.
- A questo punto, il passaggio fondamentale è quello di scegliere se rimandare al veterinario cellule fresche, oppure crioconservate in un medium di congelamento (a temperature tra -80 e -196 °C). Le prime sono prelevate e immerse immediatamente nella soluzione di spedizione. Le cellule metabolicamente attive o crioconservate prevedono comportamenti molto diversi da parte del veterinario che le deve utilizzare. Ma, a questo punto, occorre porsi una domanda fondamentale: le cellule mesenchimali stromali fresche e le cellule mesenchimali stromali congelate sono equivalenti?
Cellule mesenchimali stromali fresche o crioconservate?
Diversi lavori riportano che cellule mesenchimali stromali congelate e poi scongelate potrebbero presentare diversi problemi per quanto riguarda vitalità, capacità replicativa, metabolismo, distribuzione e homing. I dati che emergono dai diversi studi sono discordanti. Una recente analisi sistematica di tali studi è arrivata a concludere che, sebbene esista una qualche differenza tra le due scelte, non possediamo dati sostanziali per affermare che l’attività biologica sia differente nelle due modalità. Il dibattito tuttavia è ancora aperto.
Cellule fresche
Utilizzare cellule fresche presenta diversi vantaggi. Queste, infatti, arrivano pronte all’uso normalmente all’interno della siringa da utilizzare, le operazioni a carico del veterinario sono quindi minime. Gli svantaggi sono dovuti al fatto che deve esistere una perfetta combinazione tra laboratorio e veterinario, perché la finestra di tempo per il trasporto non è molto estesa.
I veicoli utilizzati per il trasporto sono di solito la soluzione salina 0,9% e quella di Ringer lattato, oppure il lisato piastrinico o plasma povero di piastrine, che si ricava da derivati plasmatici autologhi. Non sono quindi gli stessi veicoli visti per il trasporto di tessuti, in quanto questi devono essere utilizzati secondo la legge del farmaco veterinario. Temperatura e tempistiche tra invio e somministrazione sono altri elementi importanti da considerare, anche se non sappiamo ancora quali siano i parametri migliori per gestire queste situazioni. Anche in questo caso, ci sono diversi lavori che presentano risultati contrastanti.
Per cercare di trarre una conclusione ragionevolmente attendibile, si può affermare che cellule “fresche” spedite a temperatura ambiente (24-26 gradi) oppure refrigerate (2-8 gradi), devono essere utilizzate entro una finestra temporale di 24 ore.
Cellule crioconservate
Per quanto riguarda le cellule mesenchimali stromali crioconservate, queste presentano il vantaggio di poter essere congelate e conservate in clinica fino al loro utilizzo, agevolando la scelta della terapia più consona; per contro necessitano di procedure e manualità più complesse e rischiose riguardo al mantenimento della sterilità e della vitalità, oltre che apparecchiature specifiche per la centrifugazione.

Le cellule dovranno essere scongelate, trasferite in una provetta con una soluzione che allontana i contenuti con sostanze non iniettabili, centrifugate, trasferite in una siringa e somministrate. Molto spesso i medium di congelamento contengono DMSO (dimetilsulfossido), agente crioprotettivo ma che danneggia le cellule scongelate, ed è visto con sospetto perché responsabile di effetti indesiderati (anche molto gravi); oppure siero fetale bovino, che contiene proteine immunogene. Il medium di coltura non è invece utilizzabile in terapia, per la normativa vigente. Esistono prodotti privi di xenobiotici e a basso contenuto di DMSO, ma non sono utilizzabili in vivo.
Oltre a cellule autologhe sono entrati in commercio diversi prodotti autorizzati dall’EMA per la somministrazione terapeutica in cani e cavalli (esaminati nel webinar precedente). In questo modo il veterinario può procedere alla somministrazione del farmaco cellulare, che viene fornito in una apposita siringa monouso.
Gli aspetti pratici della terapia con cellule mesenchimali stromali
La prof.ssa Eleonora Iacono, del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna, con esperienza decennale in ambito di rigenerazione cellulare e MSC, ha trattato il secondo argomento della serata: “Modalità di applicazione locale ed endovenosa e dosaggi del farmaco cellulare. Aspetti pratici legati alla modalità di applicazione e corretto uso di MSCs”.
Come spiegato, le MSC non sono farmaci tradizionali e la soluzione che ha a disposizione il veterinario per la terapia non è omogenea e necessita di estrema cura per conservarne l’efficacia. Bisogna attenersi alle indicazioni del laboratorio per quanto attiene la conservazione, tempistica, e la modalità di somministrazione, tenendo conto delle dimensioni dell’ago che si utilizza. Questo deve essere di dimensione adeguata soprattutto in fase di risospensione delle cellule. Se vengono sospese con aghi di diametro inferiore a 21 G, si verifica un aumento della mortalità cellulare. Meglio dunque utilizzare un ago di 18 o 20 G oppure una pipetta da laboratorio. Anche l’iniezione delle cellule nel tessuto deve tenere conto di questo aspetto.

Bisogna aver presenti anche le possibili interazioni con farmaci utilizzati in concomitanza. Non presenta controindicazioni l’utilizzo di soluzione fisiologica, di Ringer, prp, siero, plasma, acido ialuronico, detomidina, butorfanolo, FANS, mentre si sono visti effetti negativi con xilazina, antimicrobici e corticosteroidi. Anche il momento dell’utilizzo di tali cellule è importante, spesso questo viene messo in atto come ultima chance, ma la fase che presenta migliori risultati è quella subacuta, quando l’infiammazione sta regredendo.
Applicazione topica
- L’applicazione topica principale è quella cutanea. Si utilizzano cellule sotto forma di spray, oppure sotto forma di gel prodotto con plasma arricchito di piastrine o plasma con carbossimetilcellulosa. In questo caso vengono fatte due applicazioni settimanali ripetute per quattro volte, con 5 o 10 milioni di cellule a seconda delle dimensioni della lesione.
- Applicazione topica oculare. Effettuata con un milione di cellule in 50 microlitri ogni sette giorni per 4 volte, per trattare ulcere corneali. Oppure tre volte al giorno per quindici giorni.
- Applicazione topica intrauterina. Utilizzata in cavalle con endometrite post inseminazione, alla posologia di 20 milioni di cellule in 20 ml di soluzione di cloruro di sodio allo 0,9%.
- Applicazione topica intramammaria. Utilizzata in casi di mastite da Staphilococcus aureus all’interno del capezzolo, con una soluzione di Ringer lattato contenente 25 milioni di cellule in tre ml di soluzione.
Somministrazione a livello locale
L’apparato muscolo scheletrico è stato quello più studiato, specie negli equini, sia per le patologie della specie, sia perché ha fatto da modello per le patologie umane.
- Somministrazione intra tendinea e legamentosa. Il protocollo prevede l’uso di dieci milioni di cellule, somministrate tramite siringa con ago di 21/23 G. La quantità di liquido dipende dalla dimensione della lesione. In genere è bene utilizzare poco liquido, per evitare lo scollamento di fibre e il dolore conseguente.
- Somministrazione per via endovenosa. Utilizzata in caso di lesioni diffuse sul tendine e il legamento di tutto l’arto. Si utilizza la vena cefalica dopo l’applicazione di un laccio emostatico prossimalmente rispetto al punto di inserimento del catetere, per evitare la diffusione di cellule in circolo. Si utilizzano 2,5/4,5 x 107 cellule in 2 ml, poi si lava il catetere con almeno 20 ml di soluzione di Ringer o fisiologica e il laccio viene successivamente rimosso. In alternativa può essere utilizzata l’arteria mediana, che però è sconsigliata per il rischio di formazione di trombi.
- Iniezione intra-articolare. Molto utilizzata nei casi di osteoartrite nel cane e cavallo. Sono utilizzate 10 milioni di cellule nel cavallo e nel cane da 5 a 20 milioni di cellule a seconda del tessuto di isolamento, mentre la quantità di liquido utilizzato varia da 0,3 ml a 2 ml di soluzione. Un prodotto farmaceutico è già disponibile in commercio. È una iniezione locale propriamente detta. Infatti le cellule iniettate non si distribuiscono a livello sistemico, al più raggiungono il tendine lesionato vicino all’articolazione. Solo in uno studio sul cavallo sono state rilevate pochissime cellule in circolo nelle 24 ore successive all’iniezione, che andavano scomparendo.
- Iniezione intra-muscolare. Normalmente pensiamo a questa modalità come a una somministrazione di tipo sistemico per quanto riguarda i farmaci tradizionali, ma così non è per le cellule stromali mesenchimali perché queste non sono presenti a livello sistemico dopo la somministrazione per questa via.
- Somministrazione intra-spinale. Si effettua una iniezione nello spazio epidurale attorno alla lesione, con due milioni di cellule in 500 microlitri di soluzione fisiologica, oppure una iniezione epidurale con un milione di cellule in un ml di soluzione fisiologica, con un ago tenuto a 45 gradi e continuando a iniettare mentre si sfila. Si sono ottenuti ottimi risultati in cani con patologie spinali.
- Iniezione sottocutanea e sotto-gengivale. Sono stati utilizzati dieci o venti milioni di cellule per ml attorno ai margini delle piaghe cutanee, sia nel cane che nel cavallo. Oppure iniezioni sotto-gengivali con dieci milioni di cellule in 0,2 ml di soluzione fisiologica nel cane, per il trattamento di ulcere buccali.
- Iniezione intra-oculare. Vengono somministrate 250.000 cellule in 0,25 ml per via sottocongiuntivale, in caso di ulcere corneali del cane. Possibile anche la somministrazione a livello arterioso.
Somministrazione sistemica
Viene effettuata per via endovenosa, ritenuta la via più semplice. Bisogna considerare che il primo filtro che le cellule incontrano è il polmone, quindi, per un periodo variabile da 24 ore a 7 giorni, la maggior parte delle cellule somministrate si ferma a livello polmonare; poi si distribuisce in fegato e reni e meno in altri organi, sempre sotto l’influenza di eventuali stati infiammatori presenti nell’organismo.
La quantità varia a seconda del peso dell’animale. Per quanto riguarda il cane e gatto, sono stati utilizzati da 0,2 a 2 milioni di cellule per kg di peso nel cane e 5 milioni di cellule nel gatto, mentre nel cavallo 100 milioni di cellule in 20 ml di soluzione fisiologica.
La somministrazione intra-arteriosa ha il vantaggio di saltare il filtro polmonare, con le cellule che si distribuiscono in vari organi, raggiungendo per esempio l’apparato gastroenterico o il sistema nervoso centrale, ma aumenta il rischio di trombi. Si deve utilizzare una dose minima di cellule.
Per concludere, la terapia a base di cellule stromali mesenchimali può avere un effetto positivo e deve essere tenuta in considerazione, ma il veterinario deve conoscere i limiti e le potenzialità della terapia, utilizzare la giusta via di somministrazione, la corretta quantità di cellule, stante la collaborazione continua tra clinico e laboratorista.
- 25/6/24. Gestione del trasporto e conservazione. Modalità di applicazione e dosaggi (locale, endovenosa). ↩︎